Quel cavallo rosso dell’Apocalisse
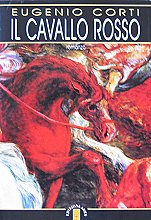 Da poco meno di due anni, anche se per ora non lo sa, o fa finta di non saperlo, la cultura italiana può vantare un nuovo grande romanzo. Uno di quei romanzi che narrano la storia, ma che sarebbero degni anche di farla, la storia letteraria e non soltanto quella, se non altro perché la rappresentazione e l’interpretazione del passato da essi proposte dovrebbe, o potrebbe, aiutare l’uomo ad affrontare le difficoltà del presente e a costruire un futuro meno peggiore di quello che i segni dei tempi lasciano intravedere. Uno di quei grandi libri che sfuggono a ogni sorta di definizione, non perché il loro argomento sia indefinito, o perché indefinibili siano le idee che danno corpo alla loro prosa, ma in quanto, per ricchezza e varietà di contenuti, mal si prestano a essere classificati, e magari archiviati, entro gli astratti e per forza di cose aridi schemi cari a tanta critica moderna.
Da poco meno di due anni, anche se per ora non lo sa, o fa finta di non saperlo, la cultura italiana può vantare un nuovo grande romanzo. Uno di quei romanzi che narrano la storia, ma che sarebbero degni anche di farla, la storia letteraria e non soltanto quella, se non altro perché la rappresentazione e l’interpretazione del passato da essi proposte dovrebbe, o potrebbe, aiutare l’uomo ad affrontare le difficoltà del presente e a costruire un futuro meno peggiore di quello che i segni dei tempi lasciano intravedere. Uno di quei grandi libri che sfuggono a ogni sorta di definizione, non perché il loro argomento sia indefinito, o perché indefinibili siano le idee che danno corpo alla loro prosa, ma in quanto, per ricchezza e varietà di contenuti, mal si prestano a essere classificati, e magari archiviati, entro gli astratti e per forza di cose aridi schemi cari a tanta critica moderna.
Il libro di cui stiamo parlando, infatti, è anche un romanzo di guerra, ma è scritto senza odio, e senza piagnistei irenistici. E’ un grande affresco di quarant’anni di vita e di lotte sociali nella penisola, ma non è animato da spirito classista. E’, in buona parte, la storia di una famiglia di imprenditori tessili; ma niente di più sbagliato che confonderlo con una sorta di sommaria sceneggiatura per una Dallas o una Dynasty all’italiana a uso e consumo di generazioni e degenerazioni di parvenus desiderosi di vedere il proprio pelo sullo stomaco ingentilito dalle graziose acconciature dell’attricetta di turno. E’ Il cavallo rosso (Ares) di Eugenio Corti: trentacinque anni di storia italiana vissuta e rivissuta, filtrata, sofferta in 1.200 pagine fitte di caratteri tipografici e di rimpianti, di sofferenze e di abiezioni, di personaggi di fantasia e di figure storiche, da Togliatti a Eugenio Cefis a Nilde Jotti; un grande romanzo corale, di ispirazione chiaramente e dichiaratamente cattolica, ultima solitaria fatica di un autore oggi ignorato dal grande pubblico, ma a suo tempo apprezzato dalla critica più severa – Benedetto Croce, Luigi Barzini, Mario Apollonio lodarono i suoi libri – ed entrato nella classifica delle grandi tirature e nelle antologie scolastiche col suo primo volume I più non ritornano che, dal ’47 al ’73 raggiunse con l’editore Garzanti le otto edizioni.
Il cavallo rosso è la storia di una generazione di giovani di varia estrazione sociale, dalla dichiarazione di guerra dell’Italia all’Inghilterra e alla Francia sino alla metà degli anni settanta. Maturati in un ambiente profondamente cattolico – quella Brianza paolotta in cui neppure il listone fascista è riuscito nel ’24 a ottenere la maggioranza e o sviluppo industriale non ha innescato un processo di secolarizzazione e di abbandono della pratica religiosa –, essi adempiono senza entusiasmo, ma con antica onestà campagnola, gli obblighi militari, portando il loro altruismo e il loro senso cristiano della vita in un mondo dove Dio sembra essere morto tra i deliri ideologici e le tempeste d’acciaio della guerra moderna.
Per la maggior parte di loro, il conflitto si svolge sul fronte russo. Qui le truppe dell’Asse – come ricorda Corti – sono all’inizio accolte con benevolenza dalla popolazione locale, in prevalenza contadini tra cui è ancor vivo il ricordo della deportazione e dello sterminio dei kulaki e che non vedono di conseguenza di malocchio l’opportunità di scuotersi di dosso il giogo bolscevico. Ma ben presto l’ottusa e brutale politica nazionalsocialista, con le sue indiscriminate rappresaglie sulla popolazione civile, induce il popolo russo a far corpo con il regime sovietico per difendersi da una minaccia ancora più grave, e per le nostre truppe, sopraffatte dal “generale inverno” e dalla mancanza di mezzi, giunge il momento di una drammatica ritirata. Una ritirata che consentirà ad alcuni protagonisti del romanzo di far ritorno fortunosamente in patria; ma si concluderà per altri nei terribili campi di concentramento sovietici, dove tra i militari di truppa, nutriti con cinquanta grammi di pane al giorno, il cannibalismo è divenuta la sola possibilità di sopravvivenza.
Al crollo del fronte russo segue quasi a ruota la caduta di Mussolini e del regime. Per i briantei, che non sono mai stati intimamente fascisti, il 25 luglio e l’8 settembre costituiscono due date accolte senza drammi né rimpianti, ma anche senza spirito di vendetta o ingiustificati entusiasmi. C’è fra di loro chi partecipa alla lotta partigiana nelle formazioni cattoliche, in cui si apprende a combattere rispettando anche la vita degli avversari catturati; e c’è chi, trovandosi al Sud, individua nella costituzione del primo nucleo del futuro esercito italiano l’occasione per sacrificare la vita a quella che egli ritiene la causa della riscossa nazionale. Una causa per la quale si è battuto con valore lo stesso Corti, che nel suo libro I poveri cristi (Garzanti) ha rievocato la sua partecipazione alla lotta dell’esercito del sud contro i Tedeschi. Giunge finalmente la fine della guerra e con essa, assieme alla pace tanto a lungo invocata, un’epoca di tensioni sociali, di acuta instabilità politica, di profonda crisi morale. Lo stesso 18 aprile del ’48, che secondo Corti avrebbe potuto costituire la premessa per la rifondazione di una civiltà cristiana, si rivela ben presto un semplice punto d’arrivo continuamente messo in discussione. Invidie laiche, dissensi interni, corruzione dilagante impediscono al partito cattolico di governare in quanto tale. Lo sviluppo economico e i trionfi del consumismo favoriscono intanto in tutti gli strati della società la diffusione di uno sfrenato egoismo, cui non sempre una cultura cattolica, afflitta da storici complessi d’inferiorità e propensa ai compromessi con i suoi nemici, riesce a porre riparo. Sinché l’esito del referendum sul divorzio non segna, come si esprime l’autore, “la fine di un ciclo di civiltà cristiana”. Un affermazione che può apparire arbitraria, ma forse non lo è più di tanto, se solo si considera che dalla legge divorzista si è passati all’aborto e da questo alla proposta (speriamo arenata) di legalizzare l’eutanasia.
Ecrire un livre, c’est toujour choisir, si dice in terra di Francia. E, sempre in terre di Francia, Henri Massais, a proposito dell’inchiesta sulla gioventù da lui pubblicata all’inizio del secolo, ebbe a commentare: “Nous n’avions per écrit un livre, nous avions fait un acte”. Anche Eugenio Corti, pubblicando il proprio romanzo, ha fatto una scelta e ha compiuto un atto. E’ una scelta, in primo luogo, di civiltà e di stile. Raccontando e commentando le vicende di un trentennio di storia, filtrate attraverso l’evoluzione della cittadina di Nomana (Besana, fuori dalla finzione romanzesca) in Brianza, l’autore non nasconde le proprie simpatie, venate di rimpianto, per un mondo permeato di spirito cristiano, in cui i rapporti tra le persone non sono stati ancora avvelenati dall’odio di classe o dalla frenesia consumistica; per un Italia alpina, secondo la felice definizione del Corti, in cui i valori come la fedeltà al dovere, il rispetto per se stessi e per i propri simili, l’orgoglio del lavoro ben fatto non si sono visti sostituiti dalla pseudoreligione del profitto o dell’invidia sociale. Ma Il cavallo rosso è anche un atto di accusa, che l’autore rivolge con esemplare chiarezza, in una prosa nitida, sorvegliata, precisa nel suo minuto realismo inframezzato da slanci di commozione e felici colpi d’ala, a un mondo che ha smarrito e rifiutato Dio, e smarrendo e rifiutando Dio ha finito per smarrire o per rifiutare anche la propria umanità. Ecco così che nelle sue pagine, come ha scritto uno dei pochi attenti recensori di questo romanzo – Cesare Cavalleri su Studi Cattolici dell’agosto/settembre 1983 –, “comunismo e nazismo sono ricondotti alla radice della loro perversione: il loro sostanziale ateismo, con il conseguente rifiuto dell’evidenza del peccato originale”. Ed ecco, anche, la condanna la condanna di una democrazia che, a furia di scendere a patti con i propri nemici, prepara il terreno su cui, in un futuro più o meno lontano, potrà scatenarsi lo sfrenato galoppo del cavallo rosso dell’Apocalisse: il simbolo biblico che dà il titolo al libro.
Si tratta, in ogni modo, di una scelta e di un gesto che Eugenio Corti si è trovato a dover abbondantemente scontare. Frutto di undici anni di lavoro e contrassegnato, nel suo respiro a tratti quasi manzoniano, da una limpidezza di tono e di lingua esemplare, il suo romanzo è potuto uscire soltanto attraverso il sostegno di una piccola casa editrice cattolica – le milanesi Edizioni Ares – ed è andato incontro a gelidi silenzi, ma anche a una più o meno dichiarata ostilità, non solo, come è ovvio e comprensibile, nel campo laicistico, ma anche in molti ambienti clericali. Silenzi e ostilità cui peraltro l’autore – come adombra, neppure troppo velatamente, nell’ultima parte de Il cavallo rosso – andò incontro anche in passato, allorché tentò di far diffondere e rappresentare la sua tragedia Processo e morte di Stalin. Per tutti questi motivi quando, poco meno di due anni fa, gli capitarono tra le mani le oltre mille e duecento pagine di questo grande affresco di storia italiana, l’autore di queste righe non poté fare a meno di guardare con rispetto, ma anche con una punta di commiserazione, alla fatica solitaria di un autore che aveva avuto il torto, o il merito, di tenere il broncio al suo tempo (e il suo tempo, come una donna rifiutata, si era vendicato tenendolo a lui); al malinconico destino di un libro che, per il semplice fatto di non essere in vetrina nelle terze pagine dei grandi quotidiani e nelle botteghe dei librai, era destinato a quella sorta di circolazione clandestina cui nella Russia sovietica sono condannate le pagine dattiloscritte dei samizdat. Qualche tempo fa, però, una notizia insperata è parsa in qualche misura smentire queste previsioni pessimistiche. Un trafiletto uscito sulle pagine letterarie di un grande quotidiano, a opera di un esponente liberale che si è rivelato anche un uomo libero, ha richiamato l’attenzione sul romanzo del Corti segnalando come esso sia giunto, nonostante il silenzio della stampa, alla sua terza edizione. Il samizdat di mille e duecento pagine a stampa, insomma, ne ha fatta di strada; anzi, oramai non si può più considerare un samizdat. Ma ora che il samizdat non è più tale, c’è da sperare che anche la critica militante – che a volte sembra militarizzata per la disciplina con cui pare accettare certe rigorose conseguenze del silenzio – riconosca a Corti quel che è di Corti e al suo libro il posto che esso merita nella letteratura italiana di questo dopoguerra.
Se le cose andassero diversamente, e se Il cavallo rosso fosse condannato a proseguire il suo solitario piccolo trotto fuori dalla cinta sacrata della repubblica delle lettere, non resterebbe che aggiungere un altro perché alle mille spiegazioni che si è soliti dare alla crisi del libro, e domandarsi se non avesse ragione Leo Longanesi quando, già negli anni Cinquanta, scriveva che in Italia non manca la libertà. Mancano soltanto gli uomini liberi.
(Enrico Nistri, 22/10/85, Il Messaggero Veneto)
