Eugenio Corti tra gli ultimi soldati del re
 Gli ultimi soldati del re sono quei soldati italiani che dal 1944 al 1945, inquadrati in quello che rimane dell’esercito regolare, hanno combattuto insieme con gli alleati contro i tedeschi. Corti, rientrato in Italia dopo la tremenda esperienza della ritirata di Russia, trascorre qualche tempo in caserma a Bolzano, viene poi trasferito a Nettunia, dove lo sorprende l’armistizio dell’8 settembre 1943, e da dove a piedi si mette in viaggio in direzione dell’Abruzzo attraverso l’Appennino; partecipa alle operazioni militari che portano allo sfondamento della linea Gustav sul Sangro e all’entrata a Chieti. Queste vicende, e tutte quelle riguardanti la guerra di liberazione, sono narrate ne Gli ultimi soldati del re che si presenta quindi come un diario dello scrittore.
Gli ultimi soldati del re sono quei soldati italiani che dal 1944 al 1945, inquadrati in quello che rimane dell’esercito regolare, hanno combattuto insieme con gli alleati contro i tedeschi. Corti, rientrato in Italia dopo la tremenda esperienza della ritirata di Russia, trascorre qualche tempo in caserma a Bolzano, viene poi trasferito a Nettunia, dove lo sorprende l’armistizio dell’8 settembre 1943, e da dove a piedi si mette in viaggio in direzione dell’Abruzzo attraverso l’Appennino; partecipa alle operazioni militari che portano allo sfondamento della linea Gustav sul Sangro e all’entrata a Chieti. Queste vicende, e tutte quelle riguardanti la guerra di liberazione, sono narrate ne Gli ultimi soldati del re che si presenta quindi come un diario dello scrittore.
Vediamo in particolare le vicende di Chieti, narrate da tre testimoni d’eccezione: oltre a Eugenio Corti, Corrado Alvaro e Luigi Paratore. La città, “umanissima” – come la definirà Corti – e tranquilla, viene a trovarsi, dopo l’armistizio dell’8 settembre, nell’occhio del ciclone. Lo scontro tra le forze alleate che tentano di risalire la penisola verso il Nord e la difesa tedesca si attesta lungo la Linea Gustav, che va da Gaeta a Ortona, località sulla costa adriatica poco più a sud di Chieti.
Nel territorio di questa provincia, intorno al fiume Sangro, i Tedeschi, prima di rassegnarsi alla ritirata, decidono di distruggere tutti i centri abitati, così come i ponti, le ferrovie, le strade e i porti, convinti come sono che “il nemico al suo arrivo non deve trovare alcuna risorsa”. La popolazione è costretta allo sfollamento: le case, evacuate, vengono minate dall’interno una per una e fatte esplodere.
Per di più, trovandosi il quartier generale della X Armata tedesca nei pressi di Avezzano, capoluogo del Fucino, non si contano i bombardamenti alleati su tutta la zona.
Nel novembre 1943 si svolge la prima grande battaglia della seconda guerra mondiale sul suolo italiano, la battaglia del Sangro, e nel mese successivo una delle più dure, quella di Ortona. Qui le perdite sono davvero ingenti: 1314 tra i civili, 1375 tra gli alleati (truppe canadesi del generale Vokes), quasi 1000 i tedeschi. A Ortona appunto è presente un grande cimitero che accoglie i caduti canadesi.
A Chieti nascono spontaneamente, come reazione alle incredibili violenze e vessazioni subite ad opera dei tedeschi in ritirata, e forse senza una precisa consapevolezza ideologica, le prime formazioni partigiane ad opera di giovani civili. Già il 9 settembre ’43 si costituisce – presso la fornace di Pietro Falco – la Banda Palombaro, che prende il nome da un paesino alle pendici della Maiella e che si scioglierà, vinta dalle rappresaglie e dalle fucilazioni operate dai tedeschi, nel febbraio ’44.
Un’altra formazione, più consistente e meglio organizzata, la Brigata Maiella, si forma a Casoli (45 km a sud del capoluogo) nel dicembre ’43, e conta tra i 400 e i 500 uomini. Parteciperà più tardi, procedendo verso il nord, alla liberazione di Bologna e di Asiago, per essere sciolta solo nel luglio ’45.
La popolazione civile d’Abruzzo vive in quei mesi un’immane tragedia: decine di migliaia di famiglie disperse e al freddo sono in cerca di riparo e di un alloggio. Una gran quantità si riversa nella città di Chieti, dove nei primi mesi del ’44 si calcola siano centomila gli sfollati, accolti dalla solidarietà e dalla proverbiale ospitalità dei cittadini. Corrado Alvaro è uno degli sfollati e racconta così la vita di allora in città.
Le angherie che fanno al piano di sotto, in casa della signora *, allo sfollato contadino Michele. Sul principio lo avevano accolto per profittare della farina e dei legumi che egli aveva portato per campare in città. Ora lo maltrattano, ora che egli non può dare più nulla. Tutta la borghesia locale, in genere, ha trattato i cafoni alla stessa maniera. I piccoli professionisti, in mezzo alla polizia, agli ospedali, ai tribunali, sono i nuovi feudatari di questa povera gente. Per tutto questo inverno si adoperarono perché i poveri contadini qui rifugiati sfollassero, nella neve, temendo di essere costretti a sfollare loro. E quelli sfollarono, con le robe in testa, i bimbi in braccio, i loro morti seppelliti in fretta. I tedeschi stessi sono stupiti di una tale mancanza di solidarietà. Ora i borghesi tremano di dovere sfollare anche loro, e non si sono accorti che i primi scacciati serviranno ad alleggerire il compito di scacciare tutti. (…)
I borghesi hanno fatto una grande processione per ringraziamento e propiziazione contro lo sfollamento. C’era tutto il clero della provincia e il meglio della città.
I poveri sono sulle vie dell’Italia centrale, a portare la vera croce. (…)
Non si finisce mai di capire. Nella casa di fronte dove mi hanno più volte chiamato per invitarmi ad andarmene, unirmi agli sfollati raminghi, fare quello che voglio purché me ne vada, m’hanno invitato a pranzo a Pasqua. Una tregua. Ma insomma, questa è un’ultima traccia di ospitalità, l’ospitalità festiva, così viva nel popolo e stranamente sopravvissuta anche fra i più avviliti e paurosi. Ad Ari, questa estate, nei poveri paesi dei contadini, non vi fu una sola casa dove, alle centinaia di soldati che tornavano in giù, a piedi, dai fronti sgretolati di Francia e di Jugoslavia, per due o tre mesi di cammino, non vi fu una casa benché povera dove rifiutassero una minestra e un pane. (…)
Non si potrebbe essere più semplici e buoni di così. Avevo preparato il mio fagotto per sfollare. Camillo era sul letto. Una delle sue sorelle mi aveva fatto intendere che me ne dovevo andare. C. chiede: «Dove andate, professore?» Dico: «Vado via». Risponde: «Fa ancora freddo, le strade sono brutte. Dove andate! Restate; Dio provvede». Sono rimasto.
(Corrado Alvaro, Quasi una vita, 1950)
La situazione in città è ben presto al limite del collasso, mentre non cessano i bombardamenti. A questo punto decide di intervenire l’arcivescovo, monsignor Giuseppe Venturi (originario di Verona, dal 1931 è vescovo della diocesi abruzzese, dove rimarrà fino alla morte avvenuta nel 1947) il quale scrive al Segretario di Stato Vaticano: “…mi aiuti a dichiarare Chieti Città Ospedaliera”. E’ l’8 dicembre 1943.
Il 21 dicembre, affrontando tutti i rischi di un viaggio in quel momento così pericoloso, si reca dal papa Pio XII, che era stato suo compagno di studi al collegio Capranica di Roma, a perorare la causa del suo gregge. A Roma incontra, oltre al Santo Padre, alti prelati e generali, tra cui il capo di Stato Maggiore tedesco, feldmaresciallo Kesserling. I colloqui tuttavia non sembrano avere l’esito sperato: nonostante la disponibilità dimostrata da Kesserling, cattolico, che Venturi incontra ben due volte sul Monte Soratte, a 50 km a Nord di Roma, il Comando tedesco ordina l’evacuazione totale di Chieti da parte dei profughi ivi affluiti.
Ma l’indomito arcivescovo non si arrende, le trattative proseguono e dopo altri passi diplomatici, grazie anche all’intervento dell’ambasciatore inglese sir Osborne, il 21 marzo ’44 arriva la dichiarazione che Chieti è Città Aperta.
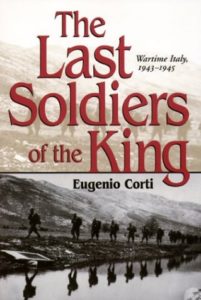 Il comando dispone che presso tutti gli accessi alla città sia collocato un cartello che nella loro lingua interdice l’ingresso alle truppe tedesche. Ecco come il famoso latinista Ettore Paratore, giovane chietino, racconta quei momenti.
Il comando dispone che presso tutti gli accessi alla città sia collocato un cartello che nella loro lingua interdice l’ingresso alle truppe tedesche. Ecco come il famoso latinista Ettore Paratore, giovane chietino, racconta quei momenti.
Che ci fosse qualcosa in vista, lo si capiva dall’affollamento veramente eccezionale al centro. Verso il Pozzo, all’altezza dei portici e del Caffè Vittoria, bisognava fare a gomitate per passare. E, quel ch’è più, all’angolo dell’Arcivescovado, la folla aveva lasciato un bello spazio vuoto e formava una specie di cordone per evitare che ci si cacciassero dentro passanti isolati, e quasi per fare ala al «venerato presule», in cui erano riposte tutte le speranze. (…)
Le facce, di solito aggrondate, dei passanti, erano atteggiate al sorriso. Nei gruppetti si conversava allegramente, ci si scambiava saluti da un crocchio all’altro, come se si fosse alla passeggiata domenicale, allo struscio per il Corso.
«Don Enrì, ci siamo. S. Giustino l’ha fatta la grazia. Quel sant’uomo di mons. Venturi l’ha spuntata. Sta per uscire dall’Arcivescovado per andare al comando tedesco a concordare la dichiarazione solenne. Anche loro, via, sono meno fetenti del solito. Non hanno fatto difficoltà, ce l’hanno avuta compassione di tanti poveretti.» (…)
Un grido, un rimbombo, un frastuono di gioia esplose e si propagò all’improvviso dalla vicina piazza S.Giustino. Voltandosi al rumore Enrico scorse uno schizzo di gente, specialmente giovani, che veniva giù correndo e gesticolando a bocca spiegata, con urla che fendevano l’aria come frecce, agitando le braccia a mulinello, facendo capriole, percorrendo su e giù metri di strada in un carosello ininterrotto, come cani in fregola. «È fatte, è fatte! L’ha fatte lu miracule! Pozz’esse benedette! Scine, scine! Siamo aperti! Nun ce ponne bumbardà! Ci potemo stà sicuri ccà dentre. Viva, viva lu vescuve!»
(Ettore Paratore, Era un’allegra brigata, 1987)
Il 26 marzo tutti si riversano in cattedrale per il Te Deum di ringraziamento e in giugno i tedeschi lasciano finalmente la città. Nel giugno del 1944, dopo la rottura della linea Gustav, la ritirata dei tedeschi apre la strada all’arrivo delle truppe italiane. Eugenio Corti, dopo aver attraversato campagne semi-abbandonate e paesini deserti, entra in città col suo reggimento d’artiglieria:
L’11 giugno il battaglione entrò in Chieti. Era domenica, giorno del Signore, e l’apparizione della città in vetta al suo colle, mi colse mentre pregavo camminando, simile a una risposta sorridente di Dio. D’un tratto prese a cadere un’acquerugiola gradevole e luminosa, che ci fece lieti. Superammo, lungo la strada asfaltata in salita, dei pacchi devastati di tritolo, accanto a buche in cui avrebbero dovuto essere deposti. La loro polvere gialla striava pigramente i rigagnoli della pioggia all’intorno. Evidentemente qui l’avanguardia paracadutista aveva sorpreso dei minatori tedeschi. Incrociammo diversi branchi di civili che scendevano verso la campagna, molti carichi di robe le spalle o il capo; ci salutavano appena, ansioso ciascuno d’arrivare a vedere cosa gli fosse rimasto.
Prima d’entrare tra le case il Decimosesto battaglione fece alt e sommariamente s’inquadrò; dietro di noi s’inquadrò il Decimoquinto. Dopo di che avanzammo a passo cadenzato, fendendo a fatica la folla che si andava facendo via via sempre più fitta, acclamava, gridava, usciva in improvvisi scroscianti battimani. Il nostro passo echeggiava marziale sull’asfalto. «Italiani! Tutti italiani! Sono i nostri soldati, e arrivano primi!…» La gente gridava in preda all’entusiasmo, ci buttava qualche fiore, cercava di toccare le nostre divise con le mani tese. “Ecco” mi dicevo, “abbiamo fatto bene a rimettere in piedi questo moncone d’esercito!” Mentre emozionato marciavo, s’affollavano nella mia mente le lunghe giornate di viaggio tra le montagne: la sferza del sole, quella di Dio, tutte le dure vicende dal giorno in cui, con l’armistizio, l’Italia era caduta in ginocchio.
(Eugenio Corti, Gli ultimi soldati del re, 1994, p.37)
Il feldmaresciallo Kesserling, nel corso del processo di Norimberga, a guerra terminata, chiederà ed otterrà da monsignor Venturi una dichiarazione attestante l’aiuto prestato per la salvezza di Chieti grazie alla quale vedrà la sua condanna a morte commutata in carcere a vita.
Il vescovo Venturi dopo la guerra sarà inserito tra i Giusti d’Israele per aver salvato moltissimi ebrei: venivano nascosti perfino nella grande cripta dellacattedrale, e insieme a numerosi partigiani, in un cimitero nelle campagne del Sangro, fiumeche attraversavano di notte per trovare salvezza nelle linee alleate.
Che differenza rispetto al comportamento del re Vittorio Emanuele III che con incredibile tempismo alle 4.50 del 9 settembre ‘43 si era messo in fuga da Roma alla volta dell’Adriatico! Proprio in Abruzzo i Savoia col loro seguito – una carovana di ben 40 automobili- fecero una pausa e trascorsero la giornata del 9 settembre ospiti del castello di Crecchio -ora sede di un Museo Archeologico-, poiché la duchessa era dama di compagnia della regina. “Nel fondo valle aggirammo, presso le macerie del paese di Crecchio -che io vedevo per la prima volta- un castello medievale dalle grossa mura frugate in tutti i modi dalle artiglierie, ma ancora saldamente in piedi.” (Eugenio Corti,ivi p.29)
Raggiunto dopo pochi chilometri il porto di Ortona, si imbarcarono nella notte per Brindisi, dove poi venne trasferito il governo.
(Silvana Rapposelli, maggio 2016, LineaTempo)
