Il cavallo rosso di Eugenio Corti
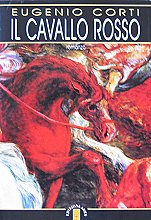 Ci sono libri che nel giro di alcuni mesi vendono migliaia di copie e che vengono recensiti da tutti i giornali. Al battage pubblicitario però spesso segue il silenzio e l’oblio. Ci sono altri libri, invece, di cui nessuno parla, ma che, noncuranti dei critici che li sdegnano, vivono una vita a parte e, edizione dopo edizione, vendono in modo modesto ma costante. Uno di questi libri “strani” è II cavallo rosso di Eugenio Corti. Massimo Lardi lo ha letto con entusiasmo e come sempre succede, quando ci si imbatte in un grande libro, si è sentito in dovere di richiamare l’attenzione su quest’opera ancora troppo sconosciuta.
Ci sono libri che nel giro di alcuni mesi vendono migliaia di copie e che vengono recensiti da tutti i giornali. Al battage pubblicitario però spesso segue il silenzio e l’oblio. Ci sono altri libri, invece, di cui nessuno parla, ma che, noncuranti dei critici che li sdegnano, vivono una vita a parte e, edizione dopo edizione, vendono in modo modesto ma costante. Uno di questi libri “strani” è II cavallo rosso di Eugenio Corti. Massimo Lardi lo ha letto con entusiasmo e come sempre succede, quando ci si imbatte in un grande libro, si è sentito in dovere di richiamare l’attenzione su quest’opera ancora troppo sconosciuta.
Perché sconosciuta? Perché un grande autore non scrive mai per piacere al pubblico così com’è, ma per creare un pubblico a cui il suo romanzo non possa non piacere, per rivelare al proprio pubblico ciò che esso dovrebbe volere, anche se non lo sa. Eugenio Corti il suo pubblico se lo è creato nel corso degli anni, se lo sta creando ancora. E in 1274 pagine egli racconta tre drammatici e movimentati decenni della nostra epoca, una mole immensa di vicende che Massimo Lardi sintetizza condensando in maniera chiara e comprensibile i contenuti narrativi delle tre parti che compongono il libro.
Una delle grandi antitesi che ha segnato la storia del nostro secolo è quella che ha visto opposti i sistemi politici totalitari a quelli basati sui principi democratici. Nel romanzo Il cavallo rosso tutto ruota attorno a questo dilemma.
Il discorso di Masssirno Nardi è sempre sorretto da un profondo senso per la giustizia storica che si traduce in una presa di posizione ferma e decisa in favore delle forze del bene. Oltre a fornirci la trama del libro, Lardi analizza alcune tecniche compositive, che Corti adotta per costruire quest’immensa epopea e per organizzare una materia narrativa quasi sterminata. Ci rivela inoltre alcune analogie che ci permettono di accostare II cavallo rosso alla Divina Commedia e a grandi romanzi storici della letteratura mondiale.
Ci sono libri che non possiamo permetterci di dimenticare e ciò non accadrà fino a quando ci sarà qualcuno che li leggerà e li racconterà agli altri.
La cultura italiana ogni tanto riserva di queste sorprese: sforna un libro che fa presa sul popolo ed è letto in tutto il mondo, ma viene snobbato dalla critica e dalla cultura ufficiale. E’ successo alla Divina Commedia, cui per secoli i letterati preferirono Il canzoniere del Petrarca mentre la gente del popolo la studiava a memoria; è successo a Pinocchio, a Le tigri di Mompracem, a Don Camillo, a II Gattopardo. Ed ora sta succedendo a Il Cavallo rosso. Ma le cose grandi a lungo non si possono tener nascoste e il meraviglioso romanzo non è sfuggito a un uomo di cultura come Michele Fazioli che l’ha presentato la primavera scorsa insieme all’autore Eugenio Corti nella sua bella rubrica «Controluce» della TSI, per cui gli siamo profondamente riconoscenti.
A leggere questo libro ho provato la sensazione di respirare a pieni polmoni e di ricrearmi finalmente in un ambiente sano e pulito. Un’emozione che si percepisce in modo particolarmente forte dopo aver bivaccato scomodamente in luoghi umidicci e puzzolenti, l’impressione che lasciano tanti altri libri osannati dalla critica. Pieno di entusiasmo ho pensato di farne dono a un parente mentre mi trovavo al mare. Ho battuto non so quante librerie. “Il cavallo rosso pubblicato da Ares? Ares Milano? Ma chi lo conosce?” Non c’era e basta. Quando finalmente ho trovato un libraio disposto a ordinarmelo ho constatato che l’ultima edizione, l’undicesima, era esaurita e che bisognava attendere la dodicesima nell’autunno 1998. Dodici edizioni in quindici anni, la prima è del maggio 1983, senza il solito battage pubblicitario: questo la dice lunga sulle qualità del romanzo.
Il quale è suddiviso in tre parti di oltre 400 pagine l’una: Il cavallo rosso, Il cavallo livido e L’albero della vita. L’intera trilogia è raccolta in un solo volume di 1274 pagine, molto piacevole da maneggiare malgrado la mole.
La narrazione abbraccia un arco di tempo di 35 anni che vanno dal 1940 al 1974 e ruota intorno ai Riva, una famiglia di imprenditori tessili di Nomana in Brianza. I membri della famiglia numerosa, con gli amici e la società della zona e numerose persone della Lombardia, della Valtellina, del Piemonte e di altre parti d’Italia, passano attraverso le esperienze della seconda guerra mondiale, prima e dopo l’armistizio, e poi partecipano alla difesa delle libertà democratiche contro il pericolo rosso, alla realizzazione del benessere, sono coinvolte nei guai della vita civile, nella lotta contro il dilagante conformismo culturale di stampo marxista e laicista. Ma Corti non si limita a fare un affresco di un importante periodo del nostro secolo, a narrare stupende storie di pace e di amore e apocalittiche storie di odio, di guerra, di prigionia, di sterminio, di lotte civili e sociali, e infine del degrado della nostra società. In una disamina stringente, anticonformista, egli cerca di scoprire anche il perché di tante mostruosità e individua nella scristianizzazione l’origine degli orrori del nazismo, del comunismo e della corruzione della società occidentale del secondo dopoguerra.
Nella prima parte della trilogia si spazia da Nomana e dalle università di Milano, in particolare la Cattolica, al mare della Romagna, alle caserme di Cremona, Mantova e Giacenza alla guerra in Russia, alla ritirata sul Don, disordinata e senza storia per gran parte delle truppe generiche italiane, eroica per i bersaglieri e le divisioni alpine della Julia e della Tridentina, in particolare per i battaglioni Morbegno, Tirano e Edolo. Di esse dirà il generale Gudenan, capo dello stato maggiore germanico, alla fine della guerra che “sono le sole formazioni di fanteria al mondo che veramente entusiasmino un militare”.
Nella seconda parte, Il cavallo livido, si raccontano le vicende dal 1943 alla fine della guerra; il ritorno dei pochi sopravvissuti, feriti e congelati, della campagna di Russia, il ritorno con mezzi di fortuna dalla campagna d’Africa, l’epilogo dell’impresa fallimentare di Albania e di Grecia, i bombardamenti delle città italiane, in particolare Milano; il crollo del fascismo, la ricostruzione di un embrione di esercito italiano a fianco degli alleati, la guerra partigiana, la repubblica della Valdossola, l’attività del Comitato Nazionale di Liberazione. Vi si leggono inoltre gli orrori dei nazisti e gli scempi subiti dalla popolazione tedesca all’avanzata dell’armata rossa. Ma la cosa inaudita è la sorte dei prigionieri negli sterminati campi di concentramento staliniani, dove finiscono migliala di prigionieri di guerra italiani e fra mille atrocità sperimentano sulla propria pelle la collaborazione di Togliatti con Stalin.
La terza parte, L’albero della vita, è invece un ampio affresco della ripresa della normalità dopo il conflitto, la costruzione di un mondo che avrebbe dovuto essere migliore: anzitutto lo studio dei reduci dalla guerra, poi i matrimoni, i figli. L’impegno delle forze veramente democratiche, il balzo in avanti nei primi cinque anni compiuto grazie al prevalere delle forze cristiane. Poi l’insabbiamento della vita civile, politica e religiosa, il diffondersi della droga, della contestazione, della violenza gratuita contro l’imprenditoria, che fa dire a uno dei protagonisti (Pierello, un semplice operaio, reduce dalla prigionia in Germania): «Possibile che gli uomini non dovessero mai, proprio mai, aver pace»? Si assiste al cedimento di tanta parte della Chiesa postconciliare e all’emarginazione e alla morte civile di chi non intende arrendersi al piatto conformismo culturale che invade tutte le istituzioni. Messa da parte l’idea della rivoluzione violenta e applicando la lezione di Gramsci, la cultura marxista tenta la conquista del potere attraverso il plagio, «cioè il progressivo condizionamento di tutti gli organi dell’informazione – come giornali, radio, televisione – nonché degli istituti culturali: scuole, case editrici, teatri, cinema». In questo modo tanti cristiani si sono fatti gli strumenti più docili del comunismo «dopo aver accettata l’analisi sedicente neutra e scientifica che della realtà fa il marxismo» (1250). Il romanzo si chiude all’epoca del referendum per il divorzio, contro il quale vari personaggi del romanzo investono ancora una volta, ma senza successo, le loro forze.
Per dare unità a questa materia sterminata, Corti ricorre a una serie di accorgimenti che rendono avvincente la lettura. Quello di presa più immediata anche sul lettore meno smaliziato, che si abbandona istintivamente alla simpatia per i personaggi, è che non c’è fatto benché minimo della storia locale, nazionale o mondiale che non sia vissuto dal punto di vista di uno dei protagonisti in modo che il lettore sia portato a gioirne o a soffrirne con lui.
Con Gerardo Riva, refrattario quanto la Brianza e la Valtellina alle idee fasciste e comuniste, il lettore vive le preoccupazioni di un padre di famiglia e di un imprenditore tessile, che vuole ad ogni costo creare nuovi posti di lavoro e preferisce lavorare in perdita che licenziare operai. La sua azienda è in qualche modo il termometro della situazione politica. Insieme a lui e a sua moglie Giulia si soffre e gioisce delle partenze e dei ritorni, dei successi e degli scacchi dei figli. Con il figlio maggiore Ambrogio, ufficiale d’artiglieria, e con il suo attendente Giovanni Paccoi, una magnifica figura di contadino umbro, si vive la campagna di Russia, si avanza e ci si ritira. Ambrogio viene ferito e salvato e prova il beatificante sollievo del ritorno in patria. Con lui si conosceranno l’ambiente studentesco e i migliori professori della Cattolica, la felicità dell’innamoramento e del matrimonio con la crocerossina Fanny Mayer, le gioie della famiglia, ma anche le preoccupazioni dell’industria e le noie della vita civile. Con il fratello partigiano Pino, che diventerà medico e si dedicherà alle cure dei diseredati in Africa, il lettore vive la nascita della repubblica di Valdossola, poi la vita di rifugiato in Svizzera, ben diversa da quella dei prigionieri in Russia. Rodolfo, il minore, si farà sacerdote e missionario. Le figlie hanno un destino di spose: Francesca e Giudittina un destino tranquillo; il lettore palpiterà in particolare per il fidanzamento e il matrimonio di Alma, soprannominata Statuina di marmo, dolcissima, forte di carattere, sposa di Michele Tintori, vero protagonista; la seguirà affascinato nella sua combattiva dedizione al marito, si rattristerà per il rovello degli insuccessi e dell’emarginazione dai centri del giornalismo, della televisione, della cultura; proverà grande dolore per la sua tragica scomparsa. Con Manno, cugino dei Riva, studente di architettura e ufficiale, si è trasportati nella campagna d’Africa, dalla quale si ritornerà avventurosamente su una semplice barca a motore. Manno si innamora di Colomba, una stupenda ragazza dai lineamenti classici, poi parte per il fronte dell’Albania e dopo l’8 settembre del 1943 segue le prime imprese dell’esercito regolare e muore combattendo per una nuova Italia a Montelungo, vicino a Monte Cassino.
L’amico e poi sposo di Alma, Michele Tintori, figlio unico di padre vedovo e grande invalido della prima guerra, studia lettere alla Cattolica, è aspirante scrittore, ufficiale volontario in Russia non per sostenere il fascismo ma per conoscere in prima persona la realtà del comunismo e poterne scrivere. Sarà fatto prigioniero e conoscerà la realtà dei campi di concentramento russi. Con lui si compie un vero e proprio viaggio agli inferi, come del resto con tutti quelli che hanno fatto la campagna di Russia. Tintori conosce le bolge della battaglia, quelle più atroci del pericolo di morire di fatica, di fame e di assideramento; ma, fatto prigioniero, scende fino in fondo alla Giudecca del sistema concentrazionario comunista. Da lì ritorna come per miracolo, scortato da una specie di Virgilio, padre Turla, il cappellano alpino pari alle più belle figure dei religiosi manzoniani. Nell’Italia del dopoguerra tocca gli ultimi termini della felicità terrena nel matrimonio con Alma Riva, che lo sostiene meravigliosamente – insieme con il suo Angelo custode – nella sua lotta per far conoscere le menzogne e la pericolosità del marxismo e per difendere i valori del cristianesimo. Uno dei quali è l’indissolubilità del matrimonio. E Corti, da quel narratore di razza che è, non si dilunga a controbattere teoricamente i preconizzati vantaggi del divorzio, ma propone alcuni fulgidi esempi di amore coniugale. Contrappone al rilassamento dei costumi la rinuncia di Ambrogio a un’avventura extraconiugale con Colomba, l’ex fidanzata di Manno e infine bellissima vedova, e ci mette davanti agli occhi lo strazio della separazione violenta, quando in una coppia profondamente affiatata e fedele un coniuge viene strappato all’altro dalla morte. Infatti Alma perisce in un incidente sul lago di Como, mentre di notte corre con la macchina incontro a Michele fermo a Dervio per un guasto alla macchina sulla via del ritorno da un giro di conferenze antidivorziste a Sondrio e a Tirano. Ma il suo Angelo custode e quello di Michele l’accompagnano nella gloria dei cicli, dove altre anime semplici, già incontrate nel romanzo, l’aspettano.
Insieme agli intellettuali e ai borghesi ci sono tanti personaggi di estrazione popolare, contadina e operaia. E sempre sono considerati insieme alle loro famiglie, ai padri, alle madri, ai fratelli, alle sorelle, alle fidanzate, alle mogli, ai figli e agli amici. Per cui le preoccupazioni, lo strazio dei lutti e dei traviamenti o la gioia dei ritorni e dei successi hanno sempre una doppia risonanza, quella vissuta direttamente dagli attanti e quella che riecheggia nell’animo dei famigliari. Al momento in cui il bersagliere Stefano, figlio di contadini, muore nella battaglia di Mescoff nel febbraio del 1943, sua madre, la mamm Lusia, destata «da un ticchettìo su un vetro della camera da letto», grida: «Stefano è morto! Oh, povera me, povera me» (p 323). La sorella di Stefano, Giustina, operaia negli stabilimenti dei Riva, muore di etisia, e atroce è il dolore del fidanzato Luca Sambruna, amico di Ambrogio Riva, alpino del battaglione Morbegno in Russia, ferito, salvo, per sempre democristiano militante per aver sperimentato sulla propria pelle le «delizie del paradiso dei lavoratori».
Indimenticabile lo strazio dei genitori dei tanti dispersi. Emblematico quello di due vecchietti che, avvisati ufficialmente dell’arrivo del figlio dalla prigionia in Russia, non riescono ad accettare la realtà quando risulta evidente che sono stati illusi a causa di un’omonimia: si era salvato un altro che portava lo stesso nome e cognome del figlio, con l’operaio Pierello, amico di Ambrogio, si assiste allo strazio dell’avanzata dell’armata rossa in Germania, e più tardi al suo dolore di padre a causa del traviamento del figlio, un tempo aspirante sacerdote, plagiato dalla nuova cultura marxista. Si potrebbero fare tanti altri esempi, ma basta questo per capire il messaggio di amore cristiano, di solidarietà e di pace fra tutti i membri e le classi della società, cioè l’opposto dell’odio di classe propagato dalle ideologie di estrema sinistra, che si autodefiniscono democratiche e progressiste. Basta questo per far intuire quanto profondo e articolato sia lo scavo psicologico di un’impressionante gamma di personaggi, presenti a tutto tondo e appartenenti a tutte le fasce di età, e a tutti i ceti della società.
Oltre ai protagonisti c’è una grande quantità di figure di contorno: italiani, tedeschi, russi, croati, ungheresi, albanesi, americani, sudafricani, soldati, ufficiali, partigiani, membri del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) buoni e cattivi. Moltissime comparse riescono indimenticabili grazie a una caratterizzazione magistrale per sineddoche. Qualche esempio: un seminarista un po’ espansivo si autodefinisce «candidato prete da corsa» e come tale è poi ricordato in seguito; un partigiano dalla faccia smorta diventa tuot court lo Smorto; un altro, «un orso, con dita pelose, faccia oscurata da punte di barba e un orecchio privo di lobo» riceverà il nome e cognome di Orecchio Tagliato (792); lo zio medico della crocerossina Fanny, testimone al matrimonio di lei con Ambrogio, essendo «ammanicato con l’amministrazione comunale di Milano» sarà qualificato con l’epiteto di «ammanicato» (1118). Notevole un certo Praga, voltamarsina, prima torturatore di con i fascisti poi con i comunisti.
La figura della ripetizione è sfruttata in modo magistrale con valore estetico e simbolico. Una delle ripetizioni più poetiche è il grido o il canto delle rondini, dell’aquila, dell’usignolo; quest’ultimo, come un leitmotiv esplode nei momenti di maggiore intensità emotiva dell’innamoramento, della partenza, del ritorno, della morte. Alma, in un trasporto di riconoscenza verso l’America che aveva salvato l’Italia, propone addirittura di regalare agli USA qualche migliaio di usignoli, affinchè anche gli americani potessero deliziarsi del loro canto. Ma con l’industrializzazione e lo scempio dell’ambiente gli usignoli sono spariti anche da Nomana (1267). Ossessionante è la ripetizione di «Confites, senor, confites» gridato dai ragazzini spagnoli – strappati alle famiglie dai marxisti nella guerra di Spagna e trasferiti in Russia per farne macchine di propaganda e tenuti invece come bestie nell’inferno dei campi di concentramento di Susdal. Grido che ritorna periodicamente alla mente di Michele, in particolare quando si lanciano i confetti crepitanti contro la macchina di Ambrogio nel momento paradisiaco delle nozze: «Confites, senor, confites», che costituisce una straziante antitesi con il momento presente, e un monito, nella felicità, a non dimenticare mai chi soffre e a mai abbassare la guardia contro il male.
Mi si passi, insieme alla discesa agli inferi, ancora qualche altra analogia con Dante. La più evidente mi sembra la ricerca della verità e della giustizia, la denuncia del male e della menzogna, l’esaltazione del bene, la professione di fede senza ombra di rispetto umano in perfetta rotta di collisione con tutto lo spirito del conformismo morale moderno. Come Dante nelle tre cantiche, Corti denuncia a tutto campo le atrocità del nazismo (20 milioni di vittime) – e fin qui niente di nuovo, Benigni ha spettacolarizzato il fenomeno. Ma con lo stesso impegno denuncia anche quello che i più tacciono, cioè gli orrori del comunismo, le purghe staliniane, la morte per fame di milioni di contadini, i campi di concentramento rossi (66 milioni di vittime) dove un’organizzazione meno follemente geometrica ha sortito il «vantaggio» del cannibalismo; denuncia le atrocità infinte dai comunisti alle popolazioni tedesche, polacche, rumene, ecc., denuncia lo sterminio di milioni di cambogiani, i campi di concentramento cinesi (150 milioni di vittime), gli orrori del Vietnam, finora imputati solo agli americani (denuncia insomma molte più vittime di quelle denunciate nel famoso Libro nero del comunismo di AAVV, Mondadori 1998). E come Dante inveisce contro il clero corrotto – «Quelli che usurpa in terra il luogo mio /… fatt’ha del cimitero mio cloaca…» (Paradiso, XXV11, 23 e 25) -; così Corti biasima, ma con maggior spirito di carità, quei frati e preti che tradiscono l’insegnamento di Cristo e, acclamatissimi da rossi e borghesi, sotto il copertoio della loro talare fanno il gioco dei laicisti; denuncia le ACLI che si sono accodate ai marxisti e non si possono più considerare cristiane (1259), «quei preti che hanno imboccata la via della novità e del progressismo credendo in buona fede d’interpretare un indirizzo proveniente dall’alto» (1249). Di dantesco c’è inoltre il continuo riferimento a Dio attraverso la preghiera. La preghiera che ritorna più frequente nella prima parte è la supplica, l’invocazione d’aiuto, per una buona morte; nella seconda prevale quella di ringraziamento per il pericolo scampato. Nella terza parte il protagonista Michele, malgrado tutte le delusioni in campo culturale, scioglie una preghiera di ringraziamento e di lode alla Santissima Trinità per la moglie che gli ha dato, una prece che è una sintesi del «Gloria» e dei versi 124-126 dell’ultimo canto del Paradiso: «Sia gloria al Padre, cioè all’Essere increato, sussistente di per sé: sia gloria al Figlio, che è il Pensiero eternamente pensato dall’Essere, la sua Espressione di fronte a se stesso; sia gloria allo Spirito Santo, cioè dall’Amore che procede dall’Essere e dalla sua Espressione…» (1189).
Non da ultimo, il romanzo è una trilogia anche dal punto di vista dell’amore fisico: nella prima parte l’amore è assente, o presente come un lontano miraggio dal quale ogni protagonista è escluso, magari è inseguito per lettera che spesso resta senza risposta; nella seconda l’amore è una speranza concreta, ma solo una speranza; nella terza diventa realtà attraverso il matrimonio. Quasi tutti i protagonisti, ragazze, ufficiali e soldati arrivano vergini al matrimonio: temeraria ipotesi narrativa di straordinaria pulizia morale. Ambrogio in Russia resiste alla tentazione di facili amori, conosce ne Il cavallo livido la crocerossina meravigliosa che ne L’albero della vita porterà illibata all’altare e gli darà splendidi figli. Ad essa rimarrà fedele anche quando la fedeltà comporterà per lui un sacrificio eroico. E se qualcuno dovesse credere che l’amore raccontato in questo modo sia poco avvincente, basterebbe che leggesse l’incontro di Ambrogio con Colomba da pagina 1214 a 1223 per convincersi del contrario.
Se le analogie con la Divina commedia sono facili da individuare, quelle con I promessi sposi si impongono per i luoghi, lo spirito, i temi e la forma che è quella del romanzo storico. Il centro generatore del romanzo è la Brianza con il lago di Como, il ponte di Lecco, il Resegone e Milano come città di riferimento, anche se poi l’azione si estende a gran parte del mondo e non solo all’Italia. La fiducia nella Provvidenza è indicata in tutti i protagonisti de Il cavallo rosso. Come Renzo la ringrazia quando arriva nella Milano affamata, la ringrazia Manno che arriva nella Milano bombardata: «…c’era la Provvidenza, cioè un’azione conservatrice e promotrice di Dio, nell’esercizio della quale egli si compiace di partecipare con amore anche ai casi delle sue creature più piccole… E c’era la libertà umana che – unica – può andare contro l’ordine di Dio. Così stando le cose è grazia che al male si connetta la sofferenza, la quale trattiene in qualche modo gli uomini nello scempio ch’essi possono fare del creato e di sé stessi». (630). Una fiducia maschia e realistica nella Provvidenza, che in primo luogo è senso del dovere: «Fidando in cosa? Nella Provvidenza, d’accordo, ma anche negli uomini, cioè in noi cui tocca provvedere» (997) dice Gerardo impegnato a creare posti di lavoro. Tipicamente «manzoniani» sono le partenze e i ritorni al paese, la centralità della chiesa per la comunità, una vita matrimoniale non senza noie, e soprattutto i grandi flagelli come la carestia, la guerra e la peste (campi di concentramento). I quali tuttavia in «Don Lisander», come qualche volta il Manzoni viene chiamato alla milanese nel romanzo, appaiono come calamità relativamente circoscritte, di dimensioni umane, di fronte alle catastrofi apocalittiche perpetrate nel nostro secolo da chi sulla terra ha promesso e ha cercato di realizzare il paradiso contro e senza Dio. Come suggerisce il titolo stesso dell’opera Il cavallo rosso, che è quello dell’Apocalisse.
Mi limito infine ad elencare altre analogie con grandi romanzi e scrittori, già segnalate dalla critica militante. Jorge Ipas direttore della «Gran Enciclopedia Rialp» di Madrid, afferma che ha «letto Mann, Hemingway, Camus, Lampedusa, Kafka, Musil e più della metà dei premi Nobel per la letteratura… Il cavallo rosso li supera tutti». Cesare Cavalleri in Cultura & Libri scrive che si tratta di «un romanzo che ha il respiro di Guerra e pace, l’inoppugnabilità del miglior Solgenitzin, la tenerezza ctonia del cinematografico L’albero degli zoccoli». E quanto ai pregi formali dell’opera aggiunge: «Siamo di fronte a un’opera originale e unica, che contiene in se anche i parametri della valulazione estetica. Il cavallo rosso conferma che la grande arte viene sempre dal lavoro solitario… A un’analisi strettamente letteraria, il romanzo rivela una tenuta più unica che rara. Ogni pagina è ritmicamente calibrata, le sequenze sono montate con perfetta scansione, i toni del dramma, della lirica, della tragedia, e anche dell’umorismo, si alternano, rinsaldano un’unità stilistica in cui la semplicità è il punto d’arrivo… Sono 1280 pagine nessuna delle quali è superflua, scandite in brevi sequenze quasi di taglio cinematografico e che ne rendono agevole la lettura, senza una caduta, senza un cedimento… Mi guardo intomo, mi sforzo di ricordare: non vedo nessun altro autore italiano in questo secolo, in grado di scrivere un romanzo di questa intensità, capace di compiere simili prodigi».
Non si può che applaudire.
(Massimo Lardi, gennaio 1999, Quaderni Grignonitaliani)
