L’uscita dalla sacca in Russia
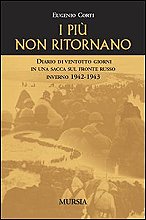 La pista, tuttora in salita, era larghissima e bianca.
La pista, tuttora in salita, era larghissima e bianca.
Quando, nonostante il flagello inenarrabile del vento, uno alzava gli occhi a guardarsi intorno, intravvedeva ancora, lontano sulla destra, il formicolare della colonna degli uomini tra le gobbe nevose. A sinistra boschi radi e spogli.
Raggiunsi infine la pianura soprastante.
Passammo davanti ad alcune postazioni campali d’artiglieria: si trattava di pezzi tedeschi, puntati verso di noi.
Dietro sporgevano dalla neve gli irregolari cumuli di terra che coprivano i ricoveri dei serventi.
Mi resi conto di cosa quelle postazioni significassero? Non ricordo chiaramente. Ricordo che davanti ai cannoni c’erano nella neve diversi soldati russi morti. Uno, un mongolo, giaceva quasi sulla pista; aveva un bel passamontagna pesante, che gli lasciava scoperti soltanto gli occhi.
Glielo tolsi; non senza fatica, perché le orecchie del morto erano di ghiaccio. Notai che il passamontagna era macchiato di sangue, sporco di sangue ghiacciato era pure il largo viso del morto.
Infilai, sopra il mio, il suo passamontagna, che di lì a poco scongelatosi alquanto, cominciò a emanare un lieve odore strano: «Odore di siberiano», pensai sorridendo; adesso però non avevo più bisogno di tenermi la coperta sul capo – sempre privo di bustina – per ripararmi dal dal vento.
Lungo quella salita si verificarono episodi odiosi.
Un ufficiale italiano offrì mille marchi (pari a settemilaseicento lire) per stare dieci minuti su una slitta tedesca. I tedeschi lo caricarono, poi, dopo tre o quattro minuti, incassato il denaro, lo rovesciarono nella neve; tanto era sfinito e non poteva far loro nulla.
Un altro diede un orologio d’oro. Alcuni, morenti dalla stanchezza, davano la pistola, ricercatissima dai tedeschi.
Si era proprio agli estremi.
Un sottufficiale tedesco – in cammino sulla pista con pochi compagni – mi avvertì cordialmente, parlando in francese, ch’eravamo entrati nelle linee amiche. Non riesco a ricordare se me n’ero già reso conto.
Valutai infine la cosa in tutta la sua portata: noi eravamo usciti dalla sacca!
Sempre camminando, il tedesco mi disse che a venti chilometri circa c’era il primo paese, Bielovodsk: stando alla radio, fra qualche chilometro avremmo trovato molti autocarri italiani, che ci avrebbero caricati tutti e portati in città. Ci sarebbero stati anche autocarri tedeschi.
Pensai con amarezza che quelli tedeschi, certo, ci sarebbero stati, ma gli italiani no.
Non sbagliavo.
Sboccammo su una magnifica strada dal fondo di ghiaccio.
La fiancheggiavano i paletti regolamentari, con un fascetto di paglia intorno alla cima, che sarebbero serviti per ritrovarla in caso di bufera o movimento di nevi.
Entrambi i rami della colonna confluirono nella strada.
Ecco un altro gruppo di lunghi cumuli di terra; ne sporgevano i tubi delle stufe dai quali uscivano scintille. Mi tornarono in mente i nostri ricoveri in riva al Don.
Eravamo proprio fuori della sacca.
Fuori della sacca!
Non avrei più dovuto fuggire come un animale braccato, con la morte alle costole. E avrei potuto rivedere i miei cari, la mia casa, l’Italia.
Dovevo scuotermi, ridere, gridare dalla gioia! Già!
Chinai il capo e ringraziai più fervidamente che potei la Madonna, che mi aveva conservato in vita.
Poi, mentre camminavo, cominciò a venire il ricordo degli altri… Pensavo con struggimento doloroso a quanti erano rimasti lungo la via del nostro calvario. Chissà se in questo momento ce n’erano di vivi in mano al nemico? Migliaia e migliaia forse? O erano stati uccisi tutti?
Zorzi!
Era andato all’assalto gridando e ridendo l’ultima volta: «Perdeva sangue da un piede come da una fontana» aveva detto Montresor. Adesso mi pareva che Zorzi mi guardasse in silenzio, con lo sguardo che aveva nella Valle della Morte.
E i miei soldati dov’erano? Gli amici modesti, senza pretese, coi quali ero vissuto per tanti mesi! Anch’essi avevano fatto tutto ciò che stava in loro per salvarsi. Ma erano rimasti irrimediabilmente indietro… «Anche noi abbiamo le nostre mamme a casa, signor tenente, ma…» (e scuotevano desolati le teste) «ma non possiamo tornare da loro».”
E tutti gli altri morti, non soltanto italiani, anche russi, anche tedeschi? Specie, fra questi ultimi, quelli che erano morti per aprirci la strada.
Cominciai a pregare per i morti.
Secondo i nostri computi, di circa 30.000 italiani del Trentacinquesimo corpo d’armata accerchiati sul Don, eravamo arrivati a Tcertkovo intorno a 8.000. La sera del 15 gennaio, includendo le truppe trovate in città al nostro arrivo, vi eravamo in circa 7.000. Ne partimmo in forse 5.000 e uscimmo dalla sacca in poco più di 4.000.
Di questi 4.000, almeno 3.000 erano congelati o feriti.
Anche gli altri mille erano in gran parte mal ridotti: rovinati nei nervi, malati, lerci.
Delle truppe di linea di un efficiente corpo d’armata non rimaneva, dopo un mese d’accerchiamento, che un pugno di miserabili, i quali a fatica si reggevano ancora in piedi. Più larve che uomini.
