La Brianza di Eugenio Corti, una terra di fede vissuta
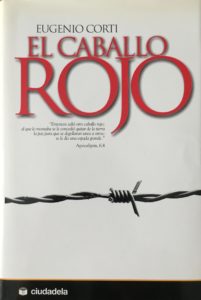 Il volto della religiosità popolare
Il volto della religiosità popolare
La tipicità della societas descritta da Corti trova il suo fondamento – lo si è già accennato – nella radicata e diffusa presenza della fede, che plasma e indirizza l’esistenza della comunità briantea.
Per definire il modo di sentire e di essere distintivo della vita in Brianza, lo scrittore fa ricorso alla terminologia popolare, che qualifica questa terra come luogo caratterizzato da una cultura “paolotta”. La definizione del termine è proposta in una delle scene che aprono Il cavallo rosso, in cui Nomana è presentata come un “paese tutto di paolotti, ossia di cattolici praticanti”.
Anche dopo la fine della guerra, pur con i cambiamenti apportati da quel diffuso e prolungato contatto con il mondo esterno, nel sentire comune appare immutata la caratterizzazione “paolotta” dei briantei, come segnala l’annotazione che, nella fabbrica di Sesto in cui lavorava, “per il solo fatto di provenire dalla Brianza Pierello era considerato un paolotto, cioè un cattolico praticante.
Alla definizione di una religiosità permeata dalla fede cattolica concretamente vissuta nei riti sacri e nei gesti della quotidianità, lo scrittore aggiunge che tale fede è segnata da una connotazione marcatamente popolare, tipica anche della maggioranza degli imprenditori briantei, quasi tutti all’origine di estrazione operaia.
Le riflessioni dell’industriale Gerardo Riva, mentre insieme ai suoi operai, il 10 giugno 1940, si dirige nella piazza di Nomana per ascoltare l’annuncio dell’entrata in guerra dell’Italia, rivelano che “la sua formazione mentale – al pari di quella di quasi tutti gli altri industriali della zona – si manteneva popolare e cristiana, come quella della restante popolazione.
Gerardo può contare su una formazione scolastica che si ferma alle elementari e la sua cultura cattolica di stampo popolare non sente il bisogno di complicate architetture teologiche né di articolate spiegazioni storico-filosofiche per impostare la vita sull’annuncio cristiano; così l’intervento del narratore, in un’ampia parentesi, interrompe il filo dei suoi pensieri presentando al lettore la prospettiva storica a cui Corti fa riferimento per delineare il panorama religioso e culturale della Brianza nella prima metà del ventesimo secolo. E se, a beneficio dei lettori, si sofferma a spiegare da dove prenda le mosse la religiosità briantea, si affretta pure subito dopo a precisare che “di ciò l’autodidatta Gerardo – e non lui solo – non aveva tuttavia cognizione”.
Lo scrittore individua una connessione tra il modificarsi del settore produttivo trainante e la religiosità dei briantei, la cui radice culturale è fatta risalire “a san Carlo e alla riforma cattolica”. Secondo la ricostruzione di Corti, “fino a quando erano prevalsi anche qui i proprietari terrieri, d’impostazione liberale e massonica come nel resto d’Italia,” la cultura cattolica popolare della gente della Brianza non aveva avuto modo di esprimersi pienamente. La situazione si modifica sensibilmente con il passaggio a un’economia basata prevalentemente sull’industria, in cui l’importanza dei proprietari terrieri viene “surclassata e addirittura cancellata da quella degli industriali d’origine operaia”. A tale provenienza sociale della classe dirigente lo scrittore collega la possibilità per la “cultura cristiana del popolo di venire a galla e affermarsi in ogni ambito” nei decenni precedenti la Seconda guerra mondiale.
La posizione di Corti è ribadita in un’altra parentesi intesa a correggere i pensieri del giovane Michele; questi, convinto della “maggior civiltà del medio evo rispetto all’evo moderno”, faceva risalire a quell’epoca “la religiosità sua e della gente di Brianza, e l’attuale religiosità cattolica in genere”. L’autore, anticipando l’evolversi delle riflessioni di Michele, precisa che in seguito egli avrebbe individuato l’origine di tale religiosità nella riforma della chiesa “avviata ben dopo il medio evo da san Carlo e dal concilio Tridentino, e tenacemente portata avanti nel corso dei secoli da innumerevoli operatori, in genere poco conosciuti perché modesti come gli apostoli e i discepoli al tempo del Signore”.
Il cavallo rosso rende diffusamente conto delle implicazioni pratiche connesse alla caratterizzazione praticante e popolare della religiosità briantea. L’aspetto più immediatamente percepibile di tale modo di vivere la fede è senza dubbio la concretezza. Il riferimento dei ‘paolotti’ a Dio passa attraverso segni che, con la loro evidenza fisica, riconducono ciascuno a prendere coscienza del senso cristiano della vita e del mondo.
È innanzitutto la chiesa a costituire, lungo tutto il corso del romanzo, un punto di riferimento, spesso presente nelle descrizioni del paese anche per la sua collocazione al termine del viale che dalla stazione sale alla piazza principale di Nomana.
All’aspetto esteriore dell’edificio sacro l’autore accenna in genere attraverso brevi tratti, connessi al passaggio di quanti vi entrano o ne escono. Particolari descrittivi ricorrenti sono le “colonne di serizzo lucente” che delimitano il pronao dell’edificio e il campanile, che in apertura della narrazione diffonde il suo “formidabile scampanio” e fa affrettare i paesani al rito della benedizione di maggio.
Proprio dall’osservazione della chiesa di Nomana sotto la luce della luna, alla vigilia delle elezioni del 1948, traggono spunto le riflessioni di Michele il quale, dopo aver fermato lo sguardo sul luogo “dove, con l’aiuto di Dio, sarebbero state un giorno benedette le sue nozze”, rimane affascinato dalla “mole verticale del campanile: da cui gli sembrava emanasse un senso di calma certezza, e anche di pace”. Per qualche istante il giovane è tentato dal desiderio di sfuggire alla nuova guerra – quella politica – che l’Italia sta vivendo; a confermarlo nell’idea che i cristiani non possano abbandonare la lotta in corso interviene l’immagine, prospettatagli dalla sua fantasia, di una guerra civile scatenata proprio intorno a quel campanile, con “sparatorie, e orrore, e sangue”.
La metamorfosi temuta dalla sbrigliata immaginazione del giovane non avviene e il prosieguo della narrazione rende conto del compimento delle attese nuziali di Michele, annotando che “il matrimonio dello scrittore e di Alma fu benedetto nella chiesa di Nomana”.
Pur essendo la chiesa, primariamente, il luogo nel quale i paesani si recano per la celebrazione dei riti minori, quali la benedizione di maggio, e della Messa domenicale, nell’economia del racconto appare funzione almeno altrettanto rilevante quella di essere un luogo di riferimento quotidiano, in cui i diversi personaggi del romanzo si recano ad affidare al Signore preoccupazioni, affanni, attese e gratitudine. Così i Riva, accompagnato alla stazione Manno, in partenza verso la destinazione assegnatagli dopo la nomina a sottotenente, acconsentono all’invito di Giulia a entrare “un momento in chiesa: «A pregare per il nostro Manno, che il Signore lo protegga»”.
E ancora, quasi a chiusura dell’episodio precedente, dopo il fortunoso ritorno del giovane dall’Africa, è di nuovo Giulia, con espressione analoga a proporre: “Dobbiamo entrare un momento in chiesa (…) a ringraziare il Signore che ti ha fatto tornare, Manno”.
In entrambe le occasioni il gruppo dei Riva trova in chiesa don Mario, il coadiutore, la prima volta immerso nella preghiera, la seconda emozionato e felice nell’accogliere il ritorno di Manno. La presenza del sacerdote – che i nomanesi rappresentati da Corti sentono come intermediario tra il popolo e Dio – appare un altro segno tangibile della concretezza della fede che anima i briantei.
Anche l’arrivo in paese di Ambrogio, dopo il ricovero in ospedale seguito alla ritirata di Russia, è segnato da un breve passaggio in chiesa. Il ritorno di questo personaggio è esplicitamente collegato a quello precedente del cugino, sia per quanto riguarda gli inviti del fratello minore Rodolfo a “raccontare qualche vicenda di guerra, come ne aveva raccontate Manno una dozzina di giorni prima”, sia per la sosta di preghiera: “Arrivati che furono in piazza anche Ambrogio – come Manno dodici giorni prima – entrò in chiesa, tallonato dagli altri due”. A differenza della volta precedente, tuttavia, “stavolta la chiesa era vuota, la grande nicchia sopra l’altar maggiore però era scoperta, e vi si scorgeva il Crocefisso circondato da un tenue alone di luce”, probabilmente lasciato esposto su richiesta dei parenti di qualche soldato in pericolo di vita.
Fatta eccezione per un breve cenno all’abside della chiesa, su cui “erano affrescate due file di pecore (…) le quali da sinistra e da destra convergevano mansuete verso un simbolico fonte centrale”, il Crocefisso esposto e illuminato sopra l’altar maggiore appare l’unico tratto descrittivo dell’interno dell’edificio sacro. L’attenzione del lettore è veicolata su questo particolare, isolato in un alone luminoso e posto come segno essenziale della presenza del divino tra gli uomini.
Si tratta di un segno a tal punto radicato della vita dei ‘paolotti’ nomanesi che non sorprende il ritrovarlo, attraverso riproduzioni fotografiche, nei luoghi in cui si svolge la loro esistenza, coinvolto nelle vicende più minute del loro agire quotidiano. Così nell’ufficio di Gerardo il rumore dei telai che giunge incessante attraverso i muri fa “lievemente vibrare ogni cosa, e in particolare una stampa del Crocefisso venerato nella chiesa di Nomana, appesa a una parete”.
Anche ben lontano dal paese, in Russia, Ambrogio in visita a Stefano nota che, su una parete della trincea dell’amico, fissata con un chiodo, vi è “una fotografia del Crocefisso di Nomana identica a quella che stava nell’ufficio di Gerardo, ma più piccola, formato cartolina”. A porre in evidenza, ancora una volta, la stretta connessione tra il sacrificio del Cristo e la concreta realtà degli uomini interviene l’autore, segnalando che “Stefano lasciò cadere moschetto ed elmetto sul pagliericcio sormontato dal Crocefisso”. Il particolare tornerà alla memoria di Ambrogio che, fermatosi in chiesa al rientro dalla Russia, scorge il Crocefisso esposto sull’altar maggiore e ricorda “l’immaginetta con la riproduzione di quel Crocefisso appuntata alla parete del ricovero di Stefano”.
In ogni circostanza le immagini sacre costituiscono, per i briantei del Cavallo rosso, un richiamo immediato alla concreta incidenza della fede nella loro vita. È esemplare, al proposito la vicenda della mamm Luisa che, presa dall’angoscia alla notizia della chiamata alle armi per il figlio, cerca “con gli occhi l’effigie della Madonna alla parete: una stampa popolare in cui prevaleva l’azzurro, il colore del ciclo sereno”. Nella sua percezione l’immagine finisce per rinviare direttamente alla realtà rappresentata, al punto che il modesto quadro sacro appeso nella cucina della Nomanella smarrisce il suo aspetto oggettuale e diventa “il volto amato della madre di Dio”, che riesce a calmare la madre contadina inducendola alla preghiera e ricordandole la presenza di Dio nella vita degli uomini, una presenza creduta per fede e appresa dall’esperienza “di tutta la sua vita”.
In questo episodio è un’altra immagine – ancora un’immagine mariana – a condurre Lucia al culmine del suo tragico presentimento di madre e, insieme, del suo radicamento nella fede: la cartolina raffigurante “un gruppo marmoreo della Madonna col Cristo morto sulle ginocchia” infilata in un angolo del quadro della Vergine alla parete. Attraverso le riflessioni della madre di Stefano l’autore esplicita la convinzione, più volte suggerita nel romanzo, del “mescolarsi alle cose umane del soprannaturale”, aggiungendo che questo “non esime affatto dal dolore”, come dimostra il fatto, ricordato da Lucia, “che la stessa Madonna aveva avuto ucciso il proprio adorabile figlio”.
La funzione di guidare i credenti all’incontro personale con Dio è, nel Cavallo rosso, costantemente individuata come caratteristica peculiare delle immagini semplici ed efficaci della religiosità popolare: dall’oleografia che raffigura sant’Antonio abate nella stalla della Nomanella alle diverse raffigurazioni della Vergine che costellano il cammino dei personaggi del romanzo invitando alla preghiera.
È la “Regina sacratissimi rosarii”, la Madonna del rosario dipinta in un’edicola sul muro esterno del giardino di casa Riva, ad aprire la fila delle immagini mariane che si snoda lungo tutta la narrazione; a lei, di ritorno dalla sua prima visita alla Nomanella, Ambrogio accenna “un inchino in segno di saluto”. A lei torna a rivolgersi tre anni dopo l’inizio della storia, ancora di ritorno dalla cascina dove vive la famiglia del suo amico Stefano, disperso in Russia, e, leggendo le parole sovrastanti l’affresco – “Regina sacratissimi rosarii ora pro nobis” – ripete “più volte la preghiera della scritta, sostituendo l”ora pro nobis’ con un ‘ora pro eo, pro eo, pro eo'”. Nuovamente l’immagine sul muro del giardino è oggetto del devoto saluto di Ambrogio che, recandosi con l’animo carico di apprensione dall’amico Luca per ricevere notizie sulla sorte di Manno, prega supplicando la Madonna “che suo cugino non fosse morto, che fosse vivo e il lungo incubo ora finalmente si dissolvesse”.
La preghiera come ritmo del vivere
Le rappresentazioni sacre rivelano, nel romanzo, una costante e inscindibile connessione con la preghiera. Ne è ben consapevole Michele che, prigioniero dei Russi a Susdal in un ex convento trasformato in lager, osserva le raffigurazioni dei santi sul muro “e ogni volta – affinché le immagini adempissero, malgrado tutto, alla funzione per cui erano state dipinte – recitava mentalmente una preghiera”.
Allo stesso modo per i popolani briantei digiuni di teorie estetiche l’arte si pone essenzialmente come strumento per indirizzare a Dio attraverso la preghiera. E, come nel caso della Madonnina dipinta su un muro del portico antistante la casa di Pierello, ciò che la rappresentazione trasmette non è il suo valore artistico, ma la fede di chi quell’immagine venera.
Così il dipinto raffigurante la Vergine di Caravaggio, che Pierello ritrova con sollievo al suo ritorno a casa dopo la guerra, con la Madonna “raffigurata in piedi, dentro un’aureola” e, di fronte a lei, “una donna in ginocchio con le braccia spalancate per il gran miracolo dell’apparizione”, è oggetto di rispettosa devozione non solo da parte del giovane operaio, ma anche dell’autore. Attraverso le riflessioni di Pierello lo scrittore nota con una sfumatura di sorridente ironia che il dipinto era stato eseguito molto tempo prima da un imbianchino “per compiacere la nonna” e in seguito più volte rinfrescato fino a rendere “decisamente troppo largo” il bordo intorno alla rappresentazione. Tuttavia, pur considerando con realismo la qualità artistica dell’opera, Corti conduce il giovane reduce a comprendere il reale valore di quel dipinto: “Quanto pregare, ad ogni modo, davanti a questa sacra immagine! Era qui che ogni sera, anche dopo morta la nonna, la famiglia usava recitare il rosario e le altre divozioni”.
Sul filo di questi pensieri viene inoltre ribadita la convinzione della reale efficacia della preghiera, con la percezione di Pierello che, ricordando il “viso invocante di sua madre”, improvvisamente ha “la cognizione che il suo ritorno di oggi fosse legato appunto a quel pregare instancabile, che ne fosse stato determinato” e, consapevole di questo, “con commossa semplicità” rivolge alla Madonna il proprio ringraziamento.
La riflessione sulle immagini sacre conduce necessariamente alla preghiera, cuore della religiosità dei briantei descritti da Corti, per i quali il raccogliersi in preghiera è gesto consueto, che scandisce la loro esistenza e del quale sono costellate le pagine del romanzo. Accanto alla particolare modalità di rivolgersi a Dio che ciascun personaggio adotta nelle diverse circostanze in cui viene a trovarsi, Il cavallo rosso presenta come invocazione ricorrente quella del rosario.
Questo – la “preghiera dei poveri” – viene recitato ogni sera nelle case dei ‘paolotti’, come l’autore ha modo di segnalare fin dalle prime pagine della narrazione. La sera del 10 giugno 1940, dopo l’annuncio della partecipazione dell’Italia alla guerra, in casa Riva “il rosario quotidiano venne recitato con più impegno del solito”, dovendosi pregare “per Manno e per la nostra patria”. Quelle invocazioni semplici e ripetute scandiscono il tempo della preghiera comune e pongono in relazione la realtà quotidiana con quella trascendente, così che “nell’intendimento di Giulia (e per riflesso di tutti gli altri) erano simili ciascuna a un toc, toc, all’uscio dell’Aldilà, secondo quell’invito del Vangelo: bussate, non stancatevi di bussare, e vi sarà aperto”.
La stessa fiducia nell’efficacia della preghiera caratterizza la recita del rosario in casa di Pierello, guidata con “viso invocante” dalla madre davanti all’immagine della Madonna di Caravaggio, “mentre le voci dei piccoli” – annota realisticamente l’autore – “si facevano lente per il sonno”.
Anche la consuetudine alla recita del rosario risentirà del cambiamento di mentalità di cui lo sviluppo del romanzo rende conto. Nelle ultime pagine del Cavallo rosso, lo scrittore Michele di passaggio attraverso la Valtellina, rievocando “le famose ‘tradotte del rosario’ di cui più volte gli avevano parlato sia don Carlo Gnocchi che Luca”, con le quali erano stati rimpatriati dalla Russia i resti di un’eroica divisione alpina, si sofferma a riflettere sulla ridotta considerazione di cui ora godeva tale preghiera: “Com’era potuto accadere che certe personalità cattoliche si mettessero prima a criticare, poi a proscrivere il rosario?”.
Lasciandosi coinvolgere dall’incalzare concitato delle riflessioni di Michele, l’autore ricorda il gesto provocatorio di “padre Bertrando” (un noto religioso la cui identità rimane velata dalla finzione narrativa), che “proprio qui, in questi posti, nel santuario circondato di pioppi della Madonna di Tirano, al termine di una predica (…) aveva teatralmente spezzata, davanti ai valligiani attoniti, una corona del rosario”. Non solo: “Nel seminario arcivescovile di F. i chierici avevano bruciate tutte le loro corone!”.
Se il mutare dei tempi spinge alcuni cattolici progressisti al boicottaggio di questa forma popolare di preghiera, Michele, al pari dei “valligiani attoniti” e fedeli, non vive alcun sentimento di inferiorità nei confronti di quelli e, pur segnato dal limite delle distrazioni e delle omissioni tipiche di ogni uomo, mantiene salda e fiduciosa la consuetudine alla preghiera quotidiana, una preghiera che non disdegna di accogliere la forma delle orazioni tradizionali, magari riplasmandola attraverso la propria sensibilità. Per questo, proseguendo il viaggio di ritorno in automobile dalla Valtellina, quando lo scrittore si ricorda “di non aver ancora recitate le preghiere di quel giorno”, dice l’angele Dei, nella forma particolare che negli anni aveva finito per dargli, cioè “rivolgendosi com’era sua abitudine non solo al proprio ma anche all’angelo della moglie”. Agli angeli invocati egli indirizza un’insistita esortazione: “Non vegliate solo su di me che sono in viaggio, ma anche su di lei, su Alma, che a quest’ora starà dormendo indifesa”.
A loro si rivolge nuovamente, poco dopo, quando, costretto da un guasto all’automobile a fermarsi al bordo della strada, rimane in attesa della moglie che ha deciso di recarsi a soccorrerlo. In sintonia con il marito anche Alma, in viaggio nella notte, per ispirazione dei due angeli – “quello gagliardo di Michele e il suo, l’angelo cortese che Dio le aveva messo accanto prima che lei nascesse, quand’era ancora nel grembo di sua madre, a custodirla fin da allora” – ripete la preghiera tante volte recitata con Michele: “Angeli di Dio che siete i nostri custodi…”. In questi ultimi istanti della vita di Alma, la preghiera consueta si carica di un significato particolare: il riferimento a Dio conduce la donna a un approfondito esame di coscienza, che si conclude con il pentimento “sul serio, cioè in modo impegnativo, non superficiale”.
Nella preghiera di Michele e Alma, al pari che in quella dei popolani ‘paolotti’, non vi è soluzione di continuità rispetto alle attività consuete della giornata né intenzione alcuna di sfuggire alle cose del mondo quanto piuttosto, e con chiara consapevolezza, il desiderio di riconoscere la presenza di Dio nelle circostanze eccezionali o quotidiane dell’esistenza.
È un tentativo di comprendere il significato di quanto accade attraverso il costante riferimento a Dio, per esempio, la preghiera di Ambrogio durante il funerale di don Carlo Gnocchi (“recitava mentalmente dei requiem, la preghiera dei morti”), da cui tuttavia di tanto in tanto si distrae “chiedendosi perché Iddio avesse tolto dalla terra don Carlo mentr’era così necessario e ancora giovane”.
Ancora Ambrogio, ormai sposato e padre di famiglia, dopo l’ultimo incontro con Colomba, la donna che aveva amato da ragazzo, alla quale aveva rinunciato e che tuttavia ancora lo attraeva molto, ricorre alla preghiera per poter meglio sostenere la pena che sta vivendo, riconducendola nella prospettiva di Dio: “Cristiano a metà (come tutti noi cristiani siamo) si aiutò con la preghiera”.
Il pregare dei briantei di Corti, collettivo o personale che sia, ha sempre e comunque per oggetto le vicende quotidiane, da quelle minime a quelle personalmente assai rilevanti come la rinnovata decisione di impostare l’esistenza sul modello indicato dal Vangelo, fino a quelle catastrofiche e di grandi proporzioni come appare, al principio del romanzo, l’annuncio dell’entrata in guerra dell’Italia. A quella notizia risuonano infatti, nella memoria dei nomanesi, le invocazioni dei loro preti “che s’erano particolarmente raffittite nelle ultime settimane: ‘A fame, a peste, a bello, libera nos Domine. Libera nos… Libera nos'”.
Come si è già accennato, nel Cavallo rosso sono numerosissimi i personaggi, principali e secondari, che si rivolgono a Dio nella preghiera. Tra i sacerdoti emerge in particolare, a questo proposito, la figura di don Mario che, nella penombra della chiesa, sta “inginocchiato in una panca a pregare solo solo, con la testa tra le mani”. La sua fiducia nell’efficacia salvifica della preghiera è rivelata dalle parole con cui, dolendosi con Manno per la cattiveria dei ragazzini più piccoli dell’oratorio, riflette tuttavia sul fatto che “poi si riesce a educarli, abbastanza, quasi tutti”. Conversando con il giovane, il sacerdote riferisce da dove provenga, a suo giudizio, l’esito positivo dell’educazione dei ragazzi: “Ma con che fatica. Quanto pregare davanti al tabernacolo!”.
Allo stesso modo Pierello, reduce dalla guerra, riconosce che il suo ritorno è dovuto alle preghiere della madre e, con fiducia non priva di concretezza, affida alla Madonna l’amico polacco con cui ha condiviso i giorni della prigionia: “Ti ringrazio e ti raccomando Tadeusz, che possa anche lui arrivare a casa sua, e che lo lascino in pace, povero diavolo”.
Tanti altri, nel romanzo, affidano a Dio nella preghiera le loro azioni. Come Luca, l’amico di Manno, alpino al fronte russo che, per aprire la strada alla colonna durante la ritirata, è costretto a sparare sui nemici con la sua mitragliatrice. L’ordine di aprire il fuoco si intreccia con l’Ave Maria che il giovane sta recitando mentalmente, così, “mentre il suo aiutante innestava nel bocchettone un caricatore dietro l’altro”, egli continua a ripetere: “Ora e nell’ora della nostra morte”. E, annota l’autore, dato che “a Luca quest’orrendo gioco non piaceva affatto”, la sua invocazione finisce per coinvolgere anche i nemici: “Gli pareva, adesso, di recitare la preghiera per quei disgraziati là sulla neve sotto i suoi colpi”.
Per quanti stanno morendo durante la ritirata prega anche Stefano, sebbene molto stanco, prima di addormentarsi e, considera l’autore, “il fatto di pregare gli aveva automaticamente riportato alla mente la soave figura di sua madre, quasi che tra la preghiera e sua madre ci fosse un nesso inscindibile: e infatti c’era, in un certo senso era proprio così”.
In effetti nel Cavallo rosso il legame tra le madri e la preghiera è costante: non solo esse guidano frequentemente la recita quotidiana del rosario in famiglia, ma con il loro esempio sollecitano i figli al continuo riferimento personale a Dio nella preghiera. Attraverso numerosi cenni (talvolta passaggi brevi ed essenziali, come nel caso della madre di Pierello e di quella di Stefano) l’autore rappresenta le madri come primo e più rilevante tramite della fede per i loro figli.
Di particolare evidenza, a questo proposito, il personaggio di Giulia, che partecipa alla preghiera comune con “tutta l’intensità e l’ardore di cui era capace”, suscitando “negli astanti la sensazione che la prima e più vera realtà per lei non fosse quella terrena e visibile, bensì l’altra, quella trascendente”. A questa realtà Giulia riconduce ogni gesto della giornata, per esempio avviando “l’abituale preghiera” prima dei pasti o suggerendo ai familiari di pregare per affidare a Dio una persona cara. È il caso, quest’ultimo, della già citata sosta in chiesa dopo la partenza di Manno (43) o dell’episodio in cui, a conclusione della visita ad Ambrogio, in convalescenziario a Riccione, raccomanda al figlio: “Prega anche tu per lui, per tuo cugino”.
È ancora Giulia, durante il bombardamento di Milano nell’agosto 1943, a pregare con accorata semplicità per quanti si trovano sotto i colpi: “Gesù e Maria (…) aiutateli, abbiate pietà di quei poveretti”. E di nuovo, prima dell’esame di laurea di Ambrogio, è lei a suggerire di passare dalla cappella dell’università, dove tutti “per qualche istante si raccolsero in sé stessi, con serietà, davanti a Dio”.
Alla profonda fede di Giulia e al suo instancabile pregare, in un momento particolarmente difficile della lunga crisi che colpisce la ditta di famiglia, i familiari attribuiscono il successo della vendita di un complesso industriale, il ricavato della quale consente di far fronte a una situazione critica: “«Le preghiere della mamma…» pensarono molti in famiglia, a cominciare da Gerardo”.
Una carità operosa
Come quella dei popolani briantei, la preghiera di Giulia, pur costituendo un’importante modalità del rapporto personale con Dio, tiene costantemente d’occhio la concretezza della situazione terrena in cui ci si trova a vivere. In tale prospettiva appare evidente come, per i briantei del romanzo, il pregare e l’agire siano generati dalla medesima radice, quella di una fede che entra profondamente nell’esistenza delle persone e ne plasma ogni istante. Proprio da tale radicalità di adesione alla fede deriva la carità a cui si conforma l’agire di Giulia, al punto che, annota l’autore, “una delle massime preferite di Giulia era ‘Sèmm al mund per vütass'”, precisando pure che si trattava di un aiutare “sul serio” e che non era costume della donna “limitarsi agli enunciati”.
Se nella vita di Giulia l’espressione pratica della fede è costituita da una carità concreta, sollecita nel soccorrere le persone in difficoltà, innumerevoli altri ‘paolotti’ spendono l’esistenza nel costante riferimento a Dio. È il caso di don Carlo Gnocchi, prima consapevole tramite della presenza di Dio tra gli alpini anche nelle situazioni più tragiche, perché “dove sono i soldati, là dev’essere anche il cappellano”, poi, dopo la guerra, attivo fondatore e guida dei “collegi per il recupero dei bambini mutilati”. O ancora quello di Manno – “giovane appassionato di Dio”, un presenza normale “nella Brianza d’allora” – che dà la vita per assolvere il compito a cui si sente chiamato.
Ed è il caso di ciascuno dei briantei che vivono della fede, siano essi i protagonisti o semplici comparse in qualche scena, personaggi appena abbozzati eppure sempre in armonia con il mondo in cui sono posti. Non si cercherà, in questa sede, di dar conto di tutti coloro che, nel romanzo, affidano la vita a Dio e adottano comportamenti esemplarmente cristiani. Tra i tanti che, ciascuno per la sua parte, contribuiscono a costituire la tipicità del mondo brianteo narrato da Corti, non si può trascurare il personaggio di don Mario Cazzaniga.
Fin dal principio della narrazione questo sacerdote è presentato come guida e modello nella fede: dal suo insegnamento – nota Ambrogio di ritorno dalla visita alla Nomanella che apre il romanzo – derivano il comportamento pudico e le parole di Giustina.
Per don Mario la preoccupazione per l’educazione dei ragazzi a lui affidati è compito costante e ineludibile, come mostra, ancora nella parte iniziale del romanzo, l’episodio in cui alcuni ragazzini dell’oratorio si divertono a tormentare un cane randagio e, poco dopo, “Aristide del Ghemio, un deficiente sui cinquant’anni, di pelle rossastra, col volto e il collo caratteristicamente deformati dal suo male”. Nella descrizione di questo episodio le scelte lessicali dell’autore pongono innanzitutto in evidenza la carità sollecita che anima i gesti e le parole del sacerdote il quale, sentite le grida del malcapitato colpito con detriti dai monelli, “uscì di corsa” dall’oratorio e, dopo aver ripreso i ragazzini, “andò verso il deficiente”, poi “tolto di tasca il fazzoletto lo ripulì di alcune macchie causate dai detriti, e si diede a parlargli con accoramento e pietà”. L’adesione di don Mario al precetto della carità appare totale e non disdegna la prossimità anche fisica con chi, dal mondo, è considerato tra gli ultimi; per questo, preso Aristide “prima per mano e poi sotto braccio, lo persuase a lasciarsi accompagnare alla sua casa”.
Lo stesso precetto della carità assume, nei confronti dei ragazzini, la forma di “una solenne reprimenda”, volta a far comprendere, oltre alla “gravita di ciò che è accaduto”, la funzione dell’oratorio e della figura stessa del sacerdote in una prospettiva di educazione alla fede.
Il successivo scambio di battute tra don Mario e Manno da modo allo scrittore di esplicitare il motivo per cui in una comunità è necessaria la presenza del sacerdote e dell’educazione cristiana: “I bambini non nascono ‘naturalmente buoni'”. È il tema, ricorrente negli scritti del nostro autore, del peccato originale insito in ogni uomo. Si tratta di un aspetto che assume notevole rilievo nella descrizione del mondo brianteo del Cavallo rosso, in quanto la realistica considerazione della presenza del peccato originale in ciascuna persona e in ciascuna comunità umana elimina ogni possibile idealizzazione utopica riguardo alle caratteristiche della societas christiana rappresentata da Corti.
Anche nella Brianza affidata alla memoria dei lettori e posta a modello per la nuova costruzione della ‘città di Dio’ tra gli uomini appaiono ineliminabili i segni del male. All’autore, tuttavia, preme chiarire come la positività dell’esempio di vita di questa comunità non stia in un’irrealizzabile rimozione del peccato originale, quanto piuttosto in un chiaro e costante riferimento a Dio, e che soltanto in questo c’è possibilità di salvezza per gli uomini. Ne è un esempio la figura appena abbozzata di Romualdo, “l’ubriaco comunale”, il quale, pur non essendo “in fase di pentimento, ma di disperazione, andava però ugualmente in chiesa”, per partecipare alla benedizione di maggio. È la fedeltà a Dio a rendere emblematica la piccola vicenda del paesano beone che, barcamenandosi tra la compunzione e la caduta nel peccato, finisce per meritare addirittura un posto nella chiusa del romanzo. Contro le aspettative del lettore, nel paradiso che l’immaginazione di Corti tenta di afferrare c’è spazio anche per Romualdo, parte di una comunità modellata dalla presenza di Dio.
In questa comunità che, pur facendo quotidianamente i conti con il peccato, vive dell’appartenenza a Dio, gli insegnamenti di don Mario costituiscono un punto di riferimento per molte persone. Già nella parte iniziale del romanzo, per mostrare quale presa abbiano le parole del sacerdote sul modo di valutare la realtà dei nomanesi, dopo l’annuncio dell’entrata in guerra dell’Italia, l’autore si inserisce nelle riflessioni dei popolani, ricordando con loro le spiegazioni di don Mario, secondo cui Dio non aveva potuto accogliere le preghiere di allontanare quel flagello, perché “i peccati degli uomini erano cresciuti al punto d’impedirglielo”. E, sempre facendo proprio, attraverso il discorso indiretto libero, il semplice ed espressivo intercalare dei paesani, aggiunge: “Chi li aveva commessi quei peccati? Dove li avevano commessi? Anche a Nomana, sì, era inutile negare: «Guardate in voi stessi, non cercate lontano» diceva don Mario, e diceva bene, appena che uno riflettesse”.
Nel Cavallo rosso, comunque, il riferimento agli insegnamenti cristiani ricevuti dal sacerdote non caratterizza soltanto un’indistinta collettività (anche se nella scrittura di Corti la coralità non annulla mai l’irripetibile individualità di ciascuno), ma ritorna come una costante anche nel comportamento di singoli personaggi che, trovandosi magari fisicamente lontani dalla comunità nomanese, recuperano nella memoria le parole di don Mario.
Così a Stefano, la cui mente “era come bloccata”, incapace di trovare un significato al “macello bestiale” in cui si trova coinvolto nei combattimenti sul fronte russo, “tornavano all’orecchio le accorate deprecazioni di don Mario là a Nomana”.
Con analoga espressione sono resi i pensieri di Pierello mentre, prigioniero dei tedeschi nella Prussia Orientale, sta raccogliendo i documenti e gli effetti personali di un gruppo di caduti. Oltre agli oggetti d’uso quotidiano e a qualche corona del rosario, dalle tasche di alcuni soldati uccisi emergono anche immagini pornografiche; a Pierello, che ricorda “quei discorsi di don Mario là a Nomana”, queste finiscono per apparire “in qualche modo legate, come causa ed effetto, ai brandelli d’intestini” di cui erano talvolta lordate. Perciò egli, che ha assorbito l’educazione ricevuta nella comunità d’origine, una volta formulato il giudizio morale su una situazione per lui nuova – “Al giovane le immagini pornografiche (cui non era abituato) riuscivano sconcertanti” – mette in atto un comportamento coerente con la propria fede e inizia a gettare via le foto pornografiche “anziché riporle nel sacco”.
La “smisurata tragedia” degli scontri tra l’esercito russo e quello tedesco, il cui esito sembra poter essere soltanto “una morte che si riorganizzava continuamente da sé stessa, con un’efficienza diabolica” suscita nel semplice e mite Pierello un’istintiva, acuta ribellione. Riflettendo sul proprio involontario coinvolgimento in “questa guerra di sterminio tra popoli privi di carità, privi di Dio”, con cui sente di non avere nulla in comune, fa nuovamente ricorso agli ammaestramenti del sacerdote del suo paese per cercare di comprendere a fondo che cosa sta accadendo intorno a lui: “Gli uni e gli altri avevano respinto Dio – come s’esprimeva don Mario là a Nomana – ed eccone qui i frutti”.
Ancora più esplicitamente, ad anni di distanza dalla guerra, è Luca a chiarire la funzione di educazione alla fede e alla comprensione della realtà svolta dal sacerdote. Parlando con il Foresto, il capo dei comunisti nomanesi, che, gravemente ammalato, si rivolge a lui per cercare di avvicinarsi al fatto cristiano, Luca lo accompagna per quanto possibile “a brancicare tra i grandi perché: la vita, la morte, il destino eterno”. Poi, facendo ricorso alla propria esperienza personale, gli propone di riferirsi anche a don Mario: “Lui di queste cose ne sa infinitamente più di me, tanto che quand’ero al fronte io per capire pensavo a quello che m’aveva insegnato lui”.
La credibilità del sacerdote nei confronti dei nomanesi sta nel suo essere uno tra “i portavoce di Dio”, uno dei “preti veri, che parlavano lo stesso, identico linguaggio da duemila anni”. Ne ha piena coscienza Ambrogio il quale, invaso dalla tentazione di adeguarsi alla mentalità corrente (siamo nel 1968) che, anche in ambito cattolico, tendeva a dar minore importanza all’adulterio, ricorda l’ammonimento di Gesù: “Ma io vi dico: se uno guarda con desiderio una donna ha già commesso peccato con lei”. E, in stretta connessione con questo, la solidità di fede dei sacerdoti che al modello di Cristo riconducono la loro azione: “E poi bastava pensare al vecchio don Mario che ora faceva il cappellano all’ospedale di Monza, e a don Carlo Gnocchi quand’era vivo”
Se gli insegnamenti di don Mario costituiscono un elemento ricorrente nel romanzo, l’adempimento del sacerdote nomanese al precetto della carità non si esaurisce nell’educazione alla fede. Come si è già avuto modo di osservare, infatti, tale opera di educazione costituisce solo una delle modalità di quell’amore per il prossimo che anima l’agire di don Mario; tra le diverse espressioni della sua carità assume notevole rilievo, non tanto per la sua immediata visibilità, quanto per gli esiti a cui giunge, la preghiera. A questa lo scrittore collega la salvezza finale dei due personaggi che, pur mescolandosi alle vicende della comunità nomanese, ne rimangono quasi fino al termine del racconto sostanzialmente estranei: il Foresto e il Praga.
Al primo, ricoverato in fin di vita nell’ospedale del paese, il sacerdote offre inizialmente – e con discrezione estrema – soltanto la propria compagnia; poi, su sua richiesta, l’aiuto ad accostarsi al mistero cristiano: “A quell’uomo condannato a morte don Mario parlò soltanto di Cristo crocefisso”.
Al termine del percorso terreno del Foresto lo scrittore sembra suggerire che è proprio la preghiera continua del sacerdote il tramite alla salvezza eterna del capo comunista. Lo riferisce Pino, che svolge la pratica medica all’ospedale del paese, ai familiari: “Mi sa che don Mario supplica ogni giorno il Signore di portarselo via: ‘Prendilo adesso, mentre è conciliato con te, prenditelo subito'”. Con lo sguardo aperto dalla sua prospettiva onnisciente, l’autore aggiunge: “E un giorno il Signore se lo prese”.
La consapevole adesione del Foresto al piano della salvezza fa sì che, anche nell’immediata percezione della gente del paese, egli diventi finalmente uno di loro, così che, annota l’autore passando dal soprannome dato per antonomasia alla semplice qualificazione, al suono della campana dell’agonia, tutti “sapevano che suonava per il Foresto, non più foresto (forestiero) ormai”. Ma non solo. L’integrazione con la comunità nomanese è realisticamente posta in evidenza in ogni aspetto, dalla condivisione dello spazio cimiteriale all’attesa della salvezza: “Anche il suo corpo venne portato nel camposanto del paese ad attendere la resurrezione, in fila con tutti gli altri”.
Così, nella scena conclusiva del romanzo, non è una sorpresa per il lettore ritrovare il Foresto in paradiso, né Marietta, che vi introduce Alma, si sofferma a giustificarne la presenza, come invece accade per il Praga. Questi, nel corso della narrazione rappresentato come un uomo posseduto dalla potenza demoniaca, inspiegabilmente chiude la rassegna dei personaggi noti al lettore e ad Alma che godono della beatitudine eterna. Spetta a Manetta rendere conto dell’apparente incongruenza: “Vedrai (…) anche il Praga d’Incastigo che – grazie alle preghiere instancabili di don Mario – il demonio non è riuscito a tenere soggiogato sino alla fine”.
La tenace fiducia del sacerdote nomanese nell’efficacia della preghiera e, insieme, la sua carità assoluta e senza distinzioni verso il prossimo, divengono strumento di salvezza anche per il personaggio che, certamente per quanto riguarda l’ambiente brianteo, ma probabilmente in tutto il romanzo, è descritto con i caratteri più negativi. La salvezza eterna del Foresto e del Praga viene inoltre a confermare l’immagine di una comunità, quella briantea, in cui nonostante tutto, resiste quella salda concretezza della fede che schiude a ciascuno la possibilità della redenzione finale. Anche se il termine della narrazione coincide con un evento – la vittoria dei divorzisti – che per Corti costituisce la fine di un periodo di civiltà, quella prospettiva di salvezza posta in atto dalla presenza di persone che vivono profondamente della fede cristiana vi si contrappone come segno ineludibile di speranza.
I segni di un mondo che cambia
II cambiamento epocale avvenuto nell’arco di tempo rappresentato dal Cavallo rosso è già preannunciato nella parte iniziale del romanzo quando – siamo nel settembre 1940 – l’autore apre un’ampia parentesi di riflessione dopo l’episodio dei maltrattamenti a un cane randagio e ad Aristide da parte dei ragazzini dell’oratorio. In questa occasione anticipa che trent’anni dopo (al termine della narrazione, dunque) “i ragazzi di Nomana non sarebbero più stati così: avrebbero tormentato meno gl’i animali, e non avrebbero più tormentato pubblicamente i deficienti”. Tuttavia – è il limite, al quale “sembra non ci sia scampo”, costituito dalle conseguenze del peccato originale nell’uomo e nelle collettività – lo scrittore prospetta ciò che appare quasi il contraltare di quell’evoluzione indubbiamente positiva: “Però avrebbero cominciato – come non era mai accaduto nella storia del paese – a odiare determinati gruppi sociali, e inoltre nessuno di loro, o quasi, sarebbe più arrivato vergine al matrimonio”.
Sono analoghe le osservazioni di Pierello che, poco dopo la fine della guerra, mentre sperimenta la nascita dell’amore per Luisina, “onesta e seria”, ma “anche spigliata quanto basta”, considera “quasi sorprendente che una ragazza così fosse in realtà semplice e pudica com’era: tutta – egli lo sapeva – casa e chiesa, e oratorio delle monache a Nomana, e lavoro laggiù nella filatura di Briosco”. L’immagine pulita della ragazza gli suscita, per contrasto, la memoria della “promiscuità spaventosa” vista durante la prigionia in Germania e Pierello, forte dell’esperienza del mondo esterno, pur con la sua limitata cultura, individua immediatamente la peculiarità di un mondo in cui “uno – anche un povero diavolo – poteva essere sicuro della donna che sarebbe diventata sua moglie”. È la moralità dei ‘paolotti’ briantei, un modo di vivere di cui il giovane sintetizza cosi le radici: “Questo – lui lo sapeva bene – non succedeva a caso: veniva dall’impegno e dall’esempio di generazioni e generazioni, dai rosari recitati ogni sera, dagli insegnamenti pazienti di suor Candida, e di don Mario, e degli altri preti ferventi come il don Piero di Briosco”.
Ancora una volta, in riferimento alla modificazione del sentire collettivo che coinvolge i personaggi del romanzo, l’autorevolezza di don Mario è assunta come guida per la comprensione della realtà. La figura del sacerdote brianteo torna nelle parole di Pierello che, ormai al termine del racconto, nel 1974, discute con la moglie delle malefatte del figlio Taddeo, soggiogato dalle teorie progressiste e sviato dall’esempio negativo del nuovo coadiutore. Gli insegnamenti di don Mario, sebbene ormai destinato ad altro incarico e lontano dal paese, continuano a costituire per Pierello il criterio di giudizio sulla realtà, al pari di quando si trovava in guerra: “Hai visto don Mario l’anno scorso quand’è venuto a Nomana per la festa del Crocefisso. Mentre io gli contavo di nostro figlio e del brutto esempio che gli da don Vittorio, gli son venute le lacrime agli occhi: non ha detto niente, però è d’accordo anche lui, e come!”.
Nelle successive riflessioni di Pierello, il nuovo sacerdote a cui è affidata l’educazione dei giovani viene ad assumere, esattamente come era accaduto per la positiva figura di don Mario, una funzione di tutto rilievo come guida e come immagine – sia pure negativa – del modo di vivere della comunità. Così don Vittorio, che “aveva come tanti altri imboccata la via delle novità e del progressismo credendo in buona fede d’interpretare un indirizzo proveniente dall’alto”, finisce per rappresentare simbolicamente la modificazione del sentire di una parte della società briantea.
“Come poteva, con un simile esempio sotto gli occhi, venir su bene la gioventù?”, si domanda l’operaio ‘paolotto’ dalla carità radicata al punto “che di proposito a quel prete egli cercava di non pensare mai”. Tuttavia Pierello, allo stesso modo che nelle riflessioni di quasi trenta anni prima, individua la connessione tra il sentire comune e le scelte etiche dei singoli: “È vero che anche senza quel prete i tempi erano cambiati, e anche qui a Nomana i rapporti tra i sessi non erano più quelli d’una volta, quand’era ragazzo lui, che la maggior parte dei maschi arrivava al matrimonio senza aver conosciuta la donna. Ah, no davvero, le cose adesso non anelavano più così”.
Non a caso il cambiamento intervenuto è legato al venir meno delle condizioni che, nella riflessione giovanile di Pierello, caratterizzavano la societas christiana briantea: l’adesione all’esempio delle generazioni precedenti, la fedeltà alla preghiera e l’insegnamento dei religiosi fedeli al Vangelo e alla tradizione della Chiesa. Così, seguendo lo scambio di battute tra i giovani progressisti nomanesi e don Vittorio, “il coadiutore rosso”, il lettore scopre che proprio il sarcasmo di quest’ultimo sulla benedizione di maggio allontana i ragazzi dalla partecipazione al rito sacro. Strettamente connessa all’abbandono della preghiera comune giunge, poco dopo, l’incondizionata approvazione del sacerdote verso il giovane ex-seminarista che disprezza i ragionamenti dei propri familiari riguardo all’intervento degli americani nel Sud-est asiatico. Si tratta di una netta cesura rispetto alla tradizione di fede e di cultura trasmessa di padre in figlio che caratterizzava il mondo brianteo all’apertura del Cavallo rosso.
La dolente considerazione sul corrompersi del mondo positivo della Brianza d’anteguerra, di cui lo smarrimento del senso della moralità è solo uno dei tanti segni, unisce Pierello e il suo autore in una domanda sconsolata, che tuttavia non chiude le porte alla speranza: “Quanto tempo sarebbe poi occorso al popolo cristiano per tornare ai propri costumi?”. Se c’è, in questo interrogativo, amara constatazione, c’è pure fiducia in un ritorno del popolo fedele all’impegno nella costruzione della città di Dio, di cui lo scrittore auspica costantemente la ripresa proprio a partire dalla consapevolezza del cambiamento intervenuto.
Al fine di illustrare le origini di questo mutamento del modo di pensare comune, che fa sentire i suoi effetti anche in Brianza, l’autore dedica alcuni cenni, posti in momenti diversi della narrazione. Come si è già notato, la società briantea viene sconvolta dalla considerevole irruzione del mondo esterno, avvenuta nel periodo della guerra e del dopoguerra. A generare il cambiamento non è tanto il confronto con il male oggettivo rappresentato dal conflitto, che i nomanesi sentono come un cataclisma inevitabile davanti al quale tuttavia “non rimaneva che rimboccarsi le maniche”, quanto piuttosto l’ingresso in una comunità semplice e fedele di un modo di pensare estraneo alle radici culturali della Brianza.
Mentre i giovani nomanesi che l’inizio del conflitto conduce lontano dalla terra d’origine fanno diretta esperienza del mondo esterno e, per la stragrande maggioranza, lo passano al vaglio di una tradizione di fede sentita in tutta la sua essenzialità anche per la situazione tragica del loro combattere, quanti restano in paese sono coinvolti dal modo di pensare di quel mondo per via della presenza degli sfollati. Questi portano con sé una mentalità cittadina assai diversa da quella paesana, dalla quale i giovani briantei si sentono attratti.
È ancora una volta don Mario a prenderne coscienza per conto della comunità a lui affidata, con una serie di considerazioni in cui la carità verso quanti hanno dovuto abbandonare le proprie case si intreccia con un’istanza pedagogica dettata dalla limpida intuizione della verità: “Povera gente, in mezzo ai disagi, bisogna compatirli. Ma in certe cose sono un po’… non sono a posto, ecco. Bisogna pur dirlo. E i ragazzi – anche i nostri dell’oratorio – e le ragazze del paese osservano tutto e devono il loro esempio”.
Se, per quanto riguarda i più giovani, il germe del cambiamento entra inizialmente a Nomana attraverso il contatto con gli sfollati, a questo si aggiunge, dopo la guerra, la propaganda svolta dagli attivisti di sinistra nelle fabbriche. Di tale modalità di diffusione in Brianza di idee del tutto estranee (anche per provenienza territoriale) alla sua cultura si rendono ben conto, alla vigilia delle elezioni del 1948, gli operai ‘paolotti’ che conversano nella sede della Democrazia cristiana nomanese. Uno di questi riferisce ad Ambrogio e Michele che “tra i rossi adesso ce n’è tanti convinti, ma proprio convinti, di vincere”. E un altro precisa: “Più che altro sono quelli che lavorano a Sesto (…). È là che gl’imbot-tiscono la testa a quel modo”.
Venti anni più tardi Ambrogio, presentando al fratello missionario Rodolfo la situazione di disordine che sta coinvolgendo il mondo del lavoro anche in Brianza, ne attribuisce parte della responsabilità anche ai “preti nuovo stile”, come il parroco di Visate (Casatenovo, fuori della metafora romanzesca), il quale era giunto a dire dal pulpito “che se non sono pagati come si deve, gli operai hanno il diritto di rubare, perché non sarebbe più un rubare”. E alle richieste di chiarimenti del fratello, in visita dall’Africa, aggiunge che tale propaganda non trova appoggio tra gli operai anziani, ma sta guastando i più giovani, “anche perché le Acli e la Cisl (…) fanno più o meno i discorsi balordi del parroco”.
Nel tentativo di spiegare e di spiegarsi in che modo si sia giunti a tale situazione, Ambrogio prosegue, quasi riflettendo a voce alta: “Io proprio non capisco cosa gli ha preso ai nostri sindacalisti: dopo il Concilio, lasciati liberi di scegliersi la strada, non hanno saputo far altro che accodarsi ai rossi, e non gl’importa se così smentiscono tutto quello che han detto e fatto prima”. L’industriale individua nell’acritica accettazione di un modo di pensare estraneo alla cultura della Brianza le ragioni della crisi di valori che coinvolge le generazioni più giovani.
La stessa perplessa estraneità rispetto alle idee progressiste è rivelata dalle riflessioni di Pierello quando, nel 1974, medita incredulo sul fatto che, nonostante il miglioramento delle condizioni economiche rispetto al passato, “non solo succedeva che i figli si ribellavano ai genitori e alle istituzioni, come il suo Taddeo, ma la più parte della gente anziché contenta sembrava diventata rabbiosa”. La spiegazione dell’operaio ‘paolotto’ attribuisce ai sindacati parte della responsabilità del generale malcontento: “Ci s’erano messi senza misericordia anche i sindacati: da quando quelli cristiani e quelli rossi si erano collegati insieme, prendevano le imprese per il collo in una maniera tale che le cose dovevano finire male per forza…”‘
Quasi a conferma dell’analisi di Pierello giungono subito dopo le affermazioni dei responsabili del comitato antidivorzista valtellinese, i quali espongono a Michele le loro preoccupazioni per l’esito dell’imminente referendum: “La vittoria qui sarebbe pacifica (…) se non fosse per gli aclisti e i nostri sindacalisti” che difendono la libertà di divorzio. Sebbene ci si trovi in un contesto territoriale non più brianteo, anche in questo caso si individua nella propaganda dei sindacalisti di sinistra nelle fabbriche il canale del passaggio di idee anticristiane in comunità tradizionalmente cattoliche.
L’ultimo – e forse più rilevante – tramite all’irruzione di un modo di pensare sostanzialmente opposto alla visione cristiana caratteristica della Brianza d’anteguerra è costituito dalla televisione. Già nella prima parte del romanzo sono anticipati alcuni effetti della presenza di tale mezzo nella educazione e nella diffusione di informazioni e modelli di vita: alla “influenza laico-umanitaria della televisione e delle idee nuove”, infatti, l’autore attribuisce la responsabilità del mutato atteggiamento morale dei giovani nomanesi tra l’inizio e la conclusione del romanzo.
“L’enorme influsso del nuovo mezzo sul pubblico” è tempestivamente compreso – già alla fine degli anni ’50 – da Michele: “«Ha più effetto dei giornali e di tutta quanta la stampa nel suo insieme» asseriva: «Finirà per forza con l’influenzare le generazioni che vengono su»”. Per questo lo scrittore vede con grande preoccupazione il controllo esercitato sulla televisione da marxisti e promarxisti, “per non scontentare i quali, i cristiani pur presenti nell’ente da tempo ormai non facevano più il discorso loro proprio, limitandosi a un discorso di compromesso”.
L’esito di quanto individuato da Michele già agli albori della diffusione del mezzo televisivo in Italia è il condizionamento del modo di pensare della gente comune, anche dei giovani contestatori briantei che ritengono di essere “affrancatori del popolo”. Su questi, considera Michele, che nell’ultima parte del romanzo è con ogni evidenza il portavoce dell’autore, sembra avere avuto pieno effetto il progetto di Gramsci, “il quale aveva indicata ai suoi la conquista del potere non per la via leninista della rivoluzione violenta, ma attraverso il plagio: attraverso cioè il progressivo condizionamento di tutti gli organi dell’informazione – come giornali, radio, televisione – nonché degli istituti culturali: scuole, case editrici, teatri, cinema”.
In effetti la situazione fotografata da Corti con il realismo consueto presenta un imponente controllo esercitato dai progressisti sulla cultura e, di conseguenza, anche sui mezzi di diffusione delle informazioni. Attraverso i pensieri del suo doppio nel romanzo, nella notte conclusiva della narrazione, l’autore ricorda che “il maggior quotidiano cattolico – quello milanese – qualche anno prima lo aveva addirittura emarginato” e che “aveva chiamato a collaborare dei comunisti tesserati”. Il risultato di tutto ciò era stato l’espropriamento culturale preconizzato dal progetto di Gramsci: “Per forza molta gioventù cristiana era oggi così ignorante, qui, come a Nomana e dappertutto, e così incredibilmente plagiata dall’avversario”.
Un compito per il lettore
In tale contesto la desolata constatazione di Michele (e del suo autore) non costituisce tuttavia l’amara conclusione del narrare. C’è – e vi si è già fatto ampio cenno – il sicuro compimento della speranza cristiana nella beatitudine senza fine che chiude il racconto. Ma insieme, nel tempo terreno, c’è il compito affidato agli uomini di buona volontà di edificare la città di Dio. A questi, innanzitutto, l’autore propone il modello etico-sociale della Brianza di un tempo.
Nelle ultime pagine del romanzo Corti dichiara esplicitamente quale finalità attribuisca alla propria opera. Attraverso l’ormai impalpabile velo dell’intermediazione di Michele, che “non aveva pubblicato quasi più, seguitando però a scrivere «per dopo il diluvio», come malinconicamente usava dire”, l’autore segnala, in un inciso dal sapore metanarrativo: “Tra l’altro aveva messo mano a una grande opera narrativa che compendiasse l’esperienza della sua generazione «per quelli che, domani, dovranno pur accingersi a ricostruire»”.
Non c’è idillio da attaccamento campanilistico né nostalgia del tempo andato nella descrizione, pur carica di affetti, dell’antico mondo brianteo di Corti. E se una vena di malinconia si ritrova nel romanzo è quella per lo smarrimento di uno stile di vita intrinsecamente positivo – dunque anche bello – sulle cui tracce si dovrà con fatica tornare. Si tratta però di una malinconia subito posta in secondo piano dalla consapevolezza del compito a cui non ci si può sottrarre.
Se insomma, per dirla con Manzoni, volessimo cavare “il sugo di tutta la storia”, non potremmo fermarci all’amarezza per la fine di un’epoca di civiltà cristiana. La Brianza di Eugenio Corti non è – mai, nemmeno all’aprirsi della narrazione – il mondo bello idealisticamente vagheggiato. Né appare la scena teatrale di un idillio infranto dalla perversione del mondo esterno. Piuttosto è lo spazio della memoria, il luogo in cui la presenza del peccato originale non elimina il costante e prevalente riferimento a Dio dei singoli e della collettività.
Ciò che innanzitutto preme al nostro autore è sollecitare il lettore a prendere parte alla ricostruzione della ‘città celeste’. Il “sugo” della storia, dunque, è una chiamata alle armi di quanti, al termine del narrare di Corti, sentano viva la nostalgia di un mondo del quale, per l’intero corso del romanzo, sono stati in qualche modo parte. Di un mondo buono, potremmo dire se il nostro autore non ci avesse messi in guardia dalla tentazione dell’utopia. Certo di un mondo – la societas christiana rappresentata nel Cavallo rosso – che, sebbene imperfetto come sempre accade alle cose degli uomini, è desiderabile modello di armonia per quanti accolgano la sfida di “accingersi a ricostruire”.
(Paola Scaglione)
