Guerra e pace in Brianza
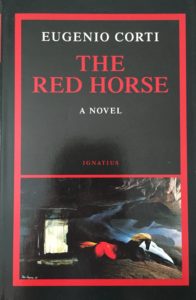 Ci sono culture che danno il meglio di sé quando volgono al tramonto. Ne possono nascere capolavori – d’arte figurativa o di letteratura, non importa – che sembrano provvidenzialmente voluti per trasmettere alle nuove culture emergenti la sintesi di un mondo di valori. Come messaggi in una bottiglia lanciati da un Titanic ormai in difficoltà; o capsule inviate nello spazio perché qualcuno, in un altro pianeta, le raccolga e sappia. Potrebbe essere questa la chiave di lettura di un libro straordinario uscito tre mesi fa a Milano e destinato, a parere di chi lo ha letto, a restare nella storia della nostra letteratura. E se finora se ne è parlato poco, soprattutto da parte della stampa laica, se non lo si è visto inserito in alcuna delle “rose” di candidati ai vari premi, questo testimonia solo la sordità di un serto mondo: ma non dovrebbe pregiudicare affatto il futuro di un’opera che, anche se esclusa dai clamori dell’effimero (forse proprio per questo), potrà trovare da sola la sua strada e vivere negli anni e nei decenni di una sua vita autonoma, punto di riferimento culturale e miniera di pagine antologiche.
Ci sono culture che danno il meglio di sé quando volgono al tramonto. Ne possono nascere capolavori – d’arte figurativa o di letteratura, non importa – che sembrano provvidenzialmente voluti per trasmettere alle nuove culture emergenti la sintesi di un mondo di valori. Come messaggi in una bottiglia lanciati da un Titanic ormai in difficoltà; o capsule inviate nello spazio perché qualcuno, in un altro pianeta, le raccolga e sappia. Potrebbe essere questa la chiave di lettura di un libro straordinario uscito tre mesi fa a Milano e destinato, a parere di chi lo ha letto, a restare nella storia della nostra letteratura. E se finora se ne è parlato poco, soprattutto da parte della stampa laica, se non lo si è visto inserito in alcuna delle “rose” di candidati ai vari premi, questo testimonia solo la sordità di un serto mondo: ma non dovrebbe pregiudicare affatto il futuro di un’opera che, anche se esclusa dai clamori dell’effimero (forse proprio per questo), potrà trovare da sola la sua strada e vivere negli anni e nei decenni di una sua vita autonoma, punto di riferimento culturale e miniera di pagine antologiche.
Il libro si intitola Il cavallo rosso. L’autore si chiama Eugenio Corti. La casa editrice è la Ares di Milano, piccola ma pugnace, l’unica che non si sia lasciata spaventare dalla mole dell’opera.
Sono infatti 1.277 pagine: il che ne fa indubbiamente uno dei romanzi di maggiore respiro del dopoguerra. Il contenuto dell’opera, che è “grosso modo” la storia di una famiglia lombarda calata nelle vicissitudini storiche, sociali e politiche dell’ultimo mezzo secolo, e soprattutto lo spirito che la informa e i paesaggi che vi si disegnano, hanno già suggerito una serie di richiami letterari. E’ stato fatto il nome di Manzoni, poi quelli di Tolstoj di Guerra e pace e di Hugo de I miserabili: e non abusivamente; anche se Il cavallo rosso finisce per avere una sua autonomia che lo distacca da tutto. Come succede, appunto, ai capolavori.
E che di capolavoro si tratti, molti non hanno dubbi. Il che non equivale a dire che l’opera sia perfetta. C’è anche qualche caduta di tono, qualche rallentamento di ritmo, qualche ripetizione, qualche lombardismo e qualche personalismo di troppo, qualche pagina di troppo.
Non tanto, però, da scalfire – a nostro modo di vedere – il valore generale del libro, che ha anche il merito, singolarissimo e quasi inaudito nell’attuale stagione letteraria italiana, di sapersi far leggere, anzi, di catturare il lettore fin dalla prima pagina, rendendolo curioso di scoprire quello che succederà nelle pagine successive. Capita così che perfino i lettori – si tratta, in genere, di lettrici – allergici alle descrizioni di combattimenti e di eventi bellici, finiscano per immergersi perdutamente nel racconto della guerra di Russia, degli scontri partigiani nell’Ossola, della battaglia di Montelungo. Spiegare come ciò possa accadere significa mettere a nudo la linea guida dell’opera, l’attenzione continuamente portata sull’uomo in un’ottica di tenerezza cristiana, che si fa carico di tutto, tutto cerca di capire, se non di dissolvere, e in nome della superiore libertà dei figli di Dio si permette di sfidare le convenzioni e di guardare agli eventi fuori dai consolidati parametri della storiografia imperante. La guerra, la Resistenza, la Liberazione, il dopo guerra, visti dal di dentro e nell’ottica di cui si diceva, sembrano nuovi e diversi: più veri.
La cultura che Eugenio Corti esprime appartiene ancora alla cristianità: termine andato in disuso e perfino esorcizzato dopo il Concilio che tuttavia si presta bene ad esprimere un tipo di società non certo perfetta, ma in cui i valori cristiani sono riconosciuti come fondamentali anche da chi non può o non vuole adeguarvisi. La Chiesa, entità spirituale o edificio di pietra, è la realtà in cui una maggioranza di convinti di riconosce e si incontra.
Storicamente, nel nostro Paese, questa concezione della vita comunitaria ha avuto, fin dai secoli passati, scarsa presa nelle città. Ma qua e là, nelle campagne, è sopravvissuta, in enclaves, via via più ridotte. La Brianza, che si estende a settentrione di Milano, è una di queste: patria di “paolotti” (il termine è solo vagamente dispregiativo, e l’autore ne fa grande uso) il cui seme non si è interamente perduto: e dalla profonda Brianza, dalla terra dei “paolotti”, viene Eugenio Corti. Questo libro non poteva nascere che qui, a Besana, nello studio severo fino a essere spoglio della casa di famiglia, dove penetra l’ombra verde di un antico giardino. La casa è, con qualche modifica di orientamento, quella descritta nel romanzo, una fabbrica ottocentesca adattata ad abitazione civile, in cui si esprime la prepotente vitalità della famiglia Riva: il padre, ex operaio divenuto industriale tessile, la madre e sette figli. Il grande locale a pianterreno – sala da pranzo, soggiorno e locale di ricevimento, tutti insieme – che prende luce da quattro finestre e da due porte finestre, ammobiliato con solidi pezzi d’anteguerra, è quello dove i Riva del romanzo si radunano a pranzare e a recitare il rosario. Ma la realtà, come sempre nelle opere d’arte, è stata liberamente interpretata. I ragazzi Corti non erano sette, come i figli Riva, ma dieci: e dieci sono rimasti, a testimonianza della splendida robustezza di una stirpe tutta lombarda. I genitori sono mancati da poco: il padre nel 1976 a 86 anni; la madre nel 1980 a 88 anni. Senza fare in tempo a vedere il romanzo del figlio in cui c’era tanto di loro e del loro mondo.
Eugenio Corti, oggi, ha 62 anni, una bella figura diritta e occhi azzurri dallo sguardo singolarmente fermo e quasi severo, lo sguardo di un giudice. Ma la severità a tempo e luogo si allenta, si illumina, sa esprimere affetto, benevolenza: il giudice è cristiano. Caso raro, forse unico, nel mondo delle lettere italiane, Eugenio Corti fa lo scrittore a tempo pieno, anche se ha alle spalle molte esperienze di vita. A cominciare dalla guerra, a cui ha partecipato da giovanissimo ufficiale. Prima la campagna di Russia, da cui è tornato con la medaglia d’argento, uno dei diciassette superstiti su un reparto di 550 artiglieri. Poi, la campagna d’Italia, al fianco degli Alleati, nella divisione Folgore. La laurea in legge. Il matrimonio con una bella ragazza umbra, che più tardi ispirerà il personaggio di Alma. Qualche anno di attività nell’industria di famiglia e infine il trionfo, definitivo e senza pentimenti, della vocazione letteraria. Non ci sono figli a cui dar conto del proprio tempo; e la moglie Alma, insegnante di lettere, attualmente preside di scuola media, comprende e accetta.
Tra i libri pubblicati finora da Corti, quello che gli ha dato maggiori soddisfazioni è stato I più non ritornano (1947), diario della ritirata di Russia, otto edizioni presso Garzanti. Piacque a Benedetto Croce. Di un altro suo libro, I poveri cristi, uscito nel 1951, è stato detto che abbia ispirato Il gattopardo (e certamente Tomasi di Lampedusa lo conobbe). L’opera peggio conosciuta, invece, è un dramma, “Processo e morte di Stalin”, fugacemente portato sulle scene in anni di filo-marxismo strisciante.
Poi la decisione di dedicarsi all’opus magnum. Sono trascorsi dodici anni da allora, e salvo due brevi iati – un periodo di sei mesi dedicato alla campagna referendaria sul divorzio; un altro periodo di sei mesi, come fondista del giornale cattolico di Como, L’ordine – tutte le giornate di Corti sono state assorbite dalla stesura della saga. Il genio, ha detto qualcuno, è una lunga pazienza. Migliaia, forse decine di migliaia di pagine, vergate a matita, cancellate e riscritte anche trenta volte, fino a quando, della stesura originale, non sono rimasti che gli accenni: “Perché il ritmo”, sostiene Corti, “è tutto”. Poi la messa “in bella”, battendo sui tasti di una vecchia Olivetti Studio 44.
Così ogni giorno, per undici anni interi: due o tre ore di preparazione, consultando libri e appunti; quattro o cinque ore di stesura. Nella stanza ordinata, intorno alla scrivania ordinata – una sola nota di stravaganza: il portamatite con diciotto matite, temperate a perfezione, – si affollano i mille personaggi del romanzo: i “doppi” dell’autore Manno, impegnato e ardente; Michele, che fa dello scrivere una missione; Ambrogio, che al ritorno dalla Campagna di Russia entra nell’industria paterna e, rinunciando ad un amore che per lui sa di profanazione – la ragazza è l’ex fidanzata di Manno –, si lega ad una giovane di città, frivola e laica quanto basta per essere iscritta tra i radical-chic; e Pino, il fratello moralmente più fragile, l’unico della famiglia che venga meno alla ferrea osservanza della castità prematrimoniale, partigiano nell’Ossola. Poi gli amici e i compagni contadini o operai. Stefano, votato ad una fine tragica; Pierello, che sarà testimone sbigottito della fuga dei civili tedeschi davanti all’avanzata dei Sovietici; Giustina, che morirà di tisi; e altri amici, e le loro famiglie, e il parroco; e conoscenze occasionali sui campi di battaglia e nelle retrovie, compagni di fuga e compagni di riscossa; e tanti personaggi pubblici, alcuni presenti con il loro vero nome.
Corrono tempi terribili, il vaglio è severo. Al Cavallo rosso, che oltre all’opera generale dà titolo alla prima parte e sta a significare, nella simbologia dell’Apocalisse, la guerra tra i popoli, succede il Cavallo livido della guerra civile e degli odi intestini; fino all’Albero della vita, promessa di rinascita non completamente mantenuta. La vicenda si ferma al 1973, l’anno del referendum sul divorzio; non a caso. E’ un’epoca che si chiude. Alma, la “statuina di marmo”, innamoratissima sposa di Michele Tintori, muore in un incidente in automobile, apparentemente banale, apparentemente inspiegabile. “Ho dovuto far morire uno dei personaggi essenziali, perché la fine non fosse gratuita”, dice Corti.
Ci sono, ne Il cavallo rosso, pagine che sembrano particolarmente destinate a far discutere; e sono anche tra le più belle. Sono le pagine, quasi un romanzo dentro il romanzo, dedicate alla Campagna di Russia, chiuse tra un inizio sommesso, la guerra dal “volto umano” in cui è ancora possibile sviluppare una trama di amicizie, trovare tempo per la lettura, la meditazione sul paesaggio, lo scambio di visite; e una conclusione tragica e scomposta, la ritirata che assomiglia ad una fuga disordinata, la prigionia, così efferata da spingere all’abiezione chi ne è vittima. Per non morire di fame, c’è chi si fa cannibale, senza neppure attendere la morte della vittima.
Non c’è nulla di inventato
Tutto vero, purtroppo, conferma l’autore; anche se, ci tiene a precisare, non tutti i campi di prigionia in Unione Sovietica ricalcavano quelli descritti nel libro. Ribadisce: “Non c’è nulla di inventato. Tutto di prima mano, sulla scorta delle mie esperienze personali; o di seconda mano, sulla base di testimonianze attendibili come quelle rese dai cappellani superstiti, padre Turla del battaglione Saluzzo, don Caneva di Cargnacco nel Friuli, il francescano padre Fiora”.
Ma la descrizione dell’orrore non è mai fine a sé stessa. Soprattutto attraverso il personaggio di Michele, Corti vuol far passare al lettore un messaggio di “messa in guardia” che è affine a quello di Solgenitsyn. Si sforza di spiegare, a sé stesso e agli altri, perché certe cose abbiano potuto succedere, nei lager tedeschi come nei Gulag sovietici; con un audace confronto tra marxismo e nazismo, entrambi mossi da “analoghi meccanismi d’odio”; il marxismo, visto come rovesciamento del cristianesimo; il nazismo, con la sua tematica della razza eletta, più propriamente come rovesciamento dell’ebraismo. E per questo meno universale del marxismo.
A fatica conclusa, in Eugenio Corti sembrano convivere due sentimenti contraddittori: la convinzione, mai proclamata, ma intuibile, di aver ben lavorato; e l’altra, che la cultura ufficiale non potrà non fare il viso dell’arme a quest’opera così fuori ordinanza, cattolica di là dai limiti di sopportazione del laicismo. Attende, con una certa serenità. Ha più tempo, ora, da dedicare al giardino: la riproduzione degli oleandri; la potatura o la sostituzione dei vecchi alberi che le tempeste estive hanno danneggiato; la aiuole da ridisegnare; gli invadenti cotoneaster e noli-me-tangere da tenere a bada. Cinque tartarughe si aggirano indisturbate nel prato; i ghiri saccheggiano diligentemente le nocciole; i merli sanno dove trovare il loro becchime. E’ un angolo di vecchia Brianza ritagliato in un tessuto urbano e rurale che sempre più si allontana dalla vecchia terra dei “paolotti”. Ma gli usignoli, la cui voce, ai tempi passati, poteva confondersi con la voce stessa della campagna briantea, ormai non abitano più qui.
(Mariagrazia Cucco, 09/10/83, Famiglia Cristiana)
